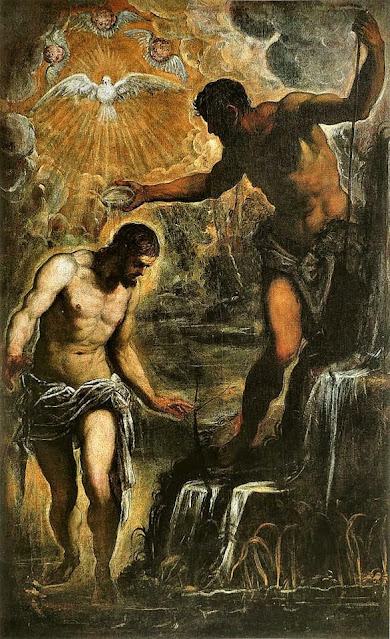Essere sale e luce
Essere sale e luce"Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa" Mt 5, 13-16.
Con queste parole Gesù faceva comprendere che il regno di Dio che stava per instaurare veniva a svilupparsi dentro alla vita delle persone e che si espandeva a partire dalla vita di coloro nei quali questo regno esisteva. Per questo parla di essere sale, di essere luce: portare il Regno di Dio non voleva dire essere dei meri divulgatori di un messaggio religioso, ma trasmettere attraverso la propria esistenza, nell’azione della grazia, la realtà personale dell’amicizia con Dio, della vita di figli di Dio.
Lo sviluppo del cristianesimo avvenne proprio così. Ciò che mosse alla fede tanti giudei e pagani – come si intravede nel racconto degli Atti - fu la spinta che proveniva dalla vita personale di coloro che credevano al Vangelo: la vita generosa e santa di una madre o di un padre di famiglia, di un militare o di un commerciante, di un impiegato imperiale o di un contadino ....., così come dei ministri della Chiesa: diaconi, presbiteri e vescovi.
L’inizio di un nuovo anno di ministero pastorale può essere per ogni presbitero l’occasione propizia per valutare, prima di ogni opportuna scelta pastorale per il nuovo anno, l’importanza primaria di essere prima di tutto sale e luce con la sua vita personale. Decidersi, con più chiarezza e determinazione, non solo a disimpegnare in modo degno il proprio ministero sacerdotale, ma a farlo cercando prima di tutto la crescita personale nella santità, per essere così sale che dà sapore, luce che illumina.
Sappiamo bene che la vocazione battesimale è chiamata alla santità e che la vocazione al sacerdozio, che in quella si manifesta, non è mera realizzazione di alcuni compiti sacri, ma chiamata a sviluppare la santità nel partecipare in un modo specifico al ministero sacerdotale di Cristo. Sappiamo anche, per esperienza, che potremmo dedicarci a un compimento anche diligente e illuminato del nostro ministero lasciando però in second’ordine – e perdendo talora di vista - la risposta a quelle chiamate che lo Spirito Santo ci rivolge attraverso lo svolgimento dei compiti del ministero: chiamate di conversione, di crescita, alla configurazione profonda con Cristo.
E' possibile scivolare nella tiepidezza: "Sei tiepido se fai pigramente e di malavoglia le cose che si riferiscono al Signore; se vai cercando con calcolo o con furbizia il modo di diminuire i tuoi doveri; se non pensi che a te stesso e alla tua comodità; se le tue conversazioni sono oziose e vane; se non aborrisci il peccato veniale; se agisci per motivi umani" (S. Josemaría Escrivá, Cammino n. 331).
Possono radicarsi atteggiamenti di imborghesimento che ci spinge verso la priorità della comodità personale e dell’affermazione di noi stessi perdendo di vista l’atteggiamento di servizio, intiepidendo il nostro zelo pastorale.
L’epoca che stiamo attraversando sottolinea a tutti i cristiani, e in primo luogo ai presbiteri, la necessità di una testimonianza di santità che emerga dalla propria vita per attrarre e disporre ad accogliere l’annuncio di Cristo. Per la diffusione dei social media si moltiplicano le parole e le immagini che parlano delle realtà evangeliche, ma l’animo umano, pur risvegliato da questi opportuni richiami, ha bisogno del contatto vivo con esistenze profondamente cristiane.
Per questo dobbiamo scacciare la tentazione di “dedicarci alle cose di Dio”, ma “senza procedere prima di tutto personalmente secondo la vita di Dio!” Non possiamo “ dare sapore”, senza essere sale, né “dare luce”, senza “essere luce”. "È necessario – ci dice S. Josemaría - che tu sia "uomo di Dio", uomo di vita interiore, uomo di preghiera e di sacrificio. - Il tuo apostolato dev'essere un traboccare della tua vita "al di dentro" (Cammino n. 961). Per questo è necessario avere a cuore di utilizzare i mezzi che il Signore ci offre per crescere nell’identificazione con Lui.
I sacramenti, di cui siamo dispensatori presso i fedeli, devono essere la nostra forza vitale. Il Sacrificio eucaristico e la Comunione al Corpo di Cristo devono essere davvero centro e radice della nostra vita quotidiana di sacerdoti. Il sacramento della Riconciliazione deve scandire per noi i passi di un cammino reale di conversione e di crescita. La relazione personale con Cristo, attraverso il dialogo sincero della meditazione quotidiana e momenti opportuni di un piano di vita spirituale quotidiano, ci sostiene e ci illumina come avvenne con i discepoli sulla via per Emmaus. È necessario coltivare la nostra formazione spirituale attraverso le opportunità che le stesse diocesi e altre istituzioni della Chiesa ci offrono.
A tutto questo deve accompagnarsi la disposizione ad affrontare la lotta interiore necessaria per seguire il Maestro: “a tutti, diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua»” Lc 9,23. Per far affermare la vita di Cristo in noi, la grazia ha bisogno di trovare la corrispondenza - per amore a Dio - della nostra lotta contro “ l’uomo vecchio”. “Lotta ascetica, intima, che ogni cristiano è tenuto a sostenere contro tutto ciò che nella sua vita non viene da Dio: la superbia, la sensualità, l'egoismo, la superficialità, la meschinità del cuore” (S. Josemaría Escrivá, E’ Gesù che passa, n. 73).
Nella Liturgia dell’ordinazione sacerdotale ci venne chiesto: “Volete essere sempre più uniti strettamente a Cristo Sommo Sacerdote che come vittima pura si è offerto al Padre per noi consacrando voi stessi a Dio insieme a lui per la salvezza degli uomini?”
E ci venne dato questo richiamo: "Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della Croce di Cristo Signore."
Tutto questo ogni giorno, viene reso possibile dalla grazia divina - se attingiamo con fede personale ai sacramenti, alla preghiera liturgica, alla preghiera di intimo dialogo con Dio - proprio attraverso i compiti che ci sono affidati nel nostro quotidiano ministero, nello snodarsi delle varie circostanze che accompagnano la nostra missione. “e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa” Mt 5, 16.
Il Cuore di Gesù, pace
dei cristiani
(nel 50° anniversario della morte di S. Josemaria,
proponiamo alcuni brani di una sua omelia pronunciata nella Solennità del S.
Cuore)
Dio Padre si è degnato di concederci, nel cuore di suo Figlio, infinitos
dilectionis thesauros, tesori inesauribili di amore, di misericordia, di
tenerezza. Per convincerci dell'evidenza dell'amor di Dio - che non solo
ascolta le nostre preghiere, ma le previene - basta seguire il ragionamento di
san Paolo: Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per
tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui?
La grazia rinnova l'uomo dall'interno e lo converte, da peccatore e ribelle, in
servo buono e fedele. E fonte di ogni grazia è l'amore che Dio nutre per noi e
che Egli stesso ci ha rivelato, non soltanto con le parole, ma con i fatti.
L'amore divino fa sì che la seconda Persona della Santissima Trinità, il Verbo
Figlio di Dio Padre, prenda la nostra carne, e cioè la nostra condizione umana,
eccetto il peccato. E il Verbo, Parola di Dio, è Verbum spirans amorem, la
Parola dalla quale procede l'Amore.
L'amore ci si rivela nell'Incarnazione, nel cammino redentore di Gesù Cristo
sulla nostra terra, fino al sacrificio supremo della Croce. E, sulla Croce, si
manifesta con un nuovo segno: Uno dei soldati gli colpì il costato con la
lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Acqua e sangue di Gesù che ci parlano
di una donazione realizzata sino in fondo, sino al consummatum est: tutto è
compiuto, per amore.
Nella festa di oggi, considerando ancora una volta i misteri centrali della
nostra fede, ci meravigliamo del modo in cui le realtà più profonde - l'amore
di Dio Padre che dona il Figlio, e l'amore del Figlio che cammina sereno verso
il Calvario - si traducano in gesti così alla portata degli uomini. Dio non si
rivolge a noi in atteggiamento di potenza e di dominio; viene a noi assumendo
la condizione di servo e divenendo simile agli uomini.
Gesù non si mostra mai lontano o altezzoso anche se nei suoi anni di
predicazione lo vediamo a volte indignato e addolorato per la malvagità degli
uomini. Ma, se facciamo attenzione, vediamo subito che il suo sdegno e la sua
ira nascono dall'amore: sono un ulteriore invito a uscire dall'infedeltà del
peccato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio - dice il Signore - o
non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva?
Queste parole ci spiegano tutta la vita di Cristo e ci fanno comprendere perché
si è presentato a noi con un cuore di carne, con un cuore come il nostro,
sicura prova di amore e testimonianza costante del mistero inenarrabile della
carità divina.
Non posso fare a meno di confidarvi una cosa che mi fa soffrire e mi spinge ad
agire: pensare agli uomini che ancora non conoscono Cristo, che non riescono
ancora a intuire la profondità del tesoro che ci attende nel Cielo, e che
camminano sulla terra come ciechi, inseguendo una gioia della quale ignorano il
vero volto o perdendosi per strade che li allontanano dall'autentica felicità.
Capisco bene ciò che l'apostolo Paolo dovette provare quella notte nella città
di Troade, quando in sogno ebbe una visione: Gli stava davanti un macedone e lo
supplicava: «Passa in Macedonia e aiutaci!». Dopo che ebbe avuto questa
visione, subito cercammo - Paolo e Timoteo - di partire per la Macedonia,
ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunciarvi la parola del Signore.
Non sentite anche voi che Dio ci chiama, che ci urge, per mezzo di tutto ciò
che accade attorno a noi, a proclamare la buona novella della venuta di Gesù?
Ma, a volte, noi cristiani rimpiccioliamo la nostra vocazione, cadiamo nella
superficialità, perdiamo il tempo in dispute e contese. O, peggio ancora, non
manca chi si scandalizza falsamente per il modo in cui alcuni vivono certi
aspetti della fede o determinate devozioni e, invece di aprir nuove strade
sforzandosi essi stessi di viverle nella maniera che ritengono retta, si
dedicano a criticare e a distruggere. Certamente possono verificarsi, e di
fatto si verificano, delle manchevolezze nella vita dei cristiani. Ma ciò che
importa non siamo noi con le nostre miserie: l'unica cosa che conta è Lui,
Gesù. È di Cristo che dobbiamo parlare, non di noi stessi.
Queste riflessioni mi vengono suggerite da alcune voci intorno a una supposta
"crisi" della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Tale crisi non
esiste; la vera devozione è stata ed è tuttora un atteggiamento vivo, pieno di
senso umano e di senso soprannaturale. I suoi frutti sono, ieri come oggi,
frutti saporosi di conversione e di donazione, di compimento della volontà di
Dio, di penetrazione amorosa dei misteri della Redenzione. Cosa ben
diversa sono invece le manifestazioni di certo sentimentalismo inefficace,
carente di dottrina e impastato di pietismo. Nemmeno a me piacciono quelle immagini
leccate, quelle figure del Sacro Cuore che non possono ispirare alcuna
devozione a persone dotate di buon senso umano e soprannaturale. Ma non si dà
prova di correttezza logica quando si trasformano certi abusi pratici,
destinati a estinguersi da soli, in problemi dottrinali e teologici.
Se crisi c'è, è quella del cuore degli uomini, che non riescono - per miopia,
per egoismo, per ristrettezza di orizzonti - a intravvedere l'insondabile amore
di Cristo nostro Signore. La liturgia con cui la Santa Chiesa celebra, fin
dalla sua istituzione, la festa del Sacro cuore, ha sempre offerto l'alimento
della vera pietà raccogliendo come lettura della Messa un testo di san Paolo
che ci propone tutto un programma di vita contemplativa - conoscenza e amore,
orazione e vita - che si fonda proprio sulla devozione al Cuore di Gesù. Dio
stesso, per bocca dell'Apostolo, ci invita a percorrere questo cammino: Cristo
abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità,
siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la
lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che
sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
La pienezza di Dio ci viene rivelata e ci viene data in Cristo, nell'amore di
Cristo, nel Cuore di Cristo. Perché è il cuore di Colui nel quale abita
corporalmente tutta la pienezza della divinità. Ma quando si perde di vista
questo grande disegno divino - la corrente d'amore instaurata nel mondo con
l'Incarnazione, la Redenzione e la Pentecoste - non si potrà mai comprendere
tutta la ricchezza del Cuore del Signore.
Prestiamo attenzione al significato profondo racchiuso in queste parole: Sacro
Cuore di Gesù. Quando parliamo del cuore umano non ci riferiamo solo ai
sentimenti, ma alludiamo a tutta la persona che vuol bene, che ama e frequenta
gli altri. Nel modo umano di esprimerci, il modo raccolto dalle Sacre Scritture
perché potessimo intendere le cose divine, il cuore è considerato come il
compendio e la fonte, l'espressione e la radice ultima dei pensieri, delle
parole e delle azioni. Un uomo, per dirla nel nostro linguaggio, vale ciò che
vale il suo cuore. Al cuore appartengono: la gioia - gioisca il mio cuore
nella tua salvezza; il pentimento - il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo
alle mie viscere; la lode a Dio - effonde il mio cuore liete parole; la
decisione di ascoltare il Signore - saldo è il mio cuore; la veglia amorosa -
io dormo, ma il mio cuore veglia; e anche il dubbio e il timore - non sia turbato
il vostro cuore, abbiate fede in me.
Il cuore non si limita a sentire: sa e capisce. La legge di Dio si scrive nel
cuore e in esso rimane scritta. La Scrittura aggiunge ancora: La bocca parla
dalla pienezza del cuore. Il Signore apostrofa gli scribi: Perché mai pensate
cose malvagie nei vostri cuori?. E, come sintesi dei peccati che l'uomo può
commettere, Gesù dice: Dal cuore provengono i propositi malvagi, gli omicidi,
gli adultèri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le
bestemmie. Quando la Sacra Scrittura parla del cuore, non intende un
sentimento passeggero che porta all'emozione o alle lacrime. Parla del cuore -
come testimonia lo stesso Gesù - per riferirsi alla persona che si rivolge
tutta, anima e corpo, a ciò che considera il suo bene: Perché là dov'è il tuo
tesoro, sarà anche il tuo cuore.
Ecco pertanto che, considerando il Cuore di Gesù, scopriamo la certezza
dell'amore di Dio e la verità del suo donarsi a noi. Nel raccomandare la
devozione al Sacro Cuore, non facciamo che raccomandare di orientare
integralmente noi stessi, con tutto il nostro essere - la nostra anima, i
nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni, le
nostre fatiche e le nostre gioie - a Gesù tutto intero. La vera devozione
al Cuore di Gesù consiste in questo: conoscere Dio e conoscere noi stessi,
guardare a Gesù e ricorrere a Lui che ci esorta, ci istruisce, ci guida. In
questa devozione non si dà altra superficialità che quella dell'uomo che, non
essendo interamente umano, non riesce a cogliere la realtà del Dio incarnato.
Gesù crocifisso, con il cuore trafitto dall'amore per gli uomini, è una
risposta eloquente - le parole sono superflue - alla domanda sul valore delle
cose e delle persone. Gli uomini, la loro vita e la loro felicità, valgono
tanto che lo stesso Figlio di Dio si dona loro per redimerli, purificarli,
elevarli. Chi non amerà quel Cuore così ferito? si domandava un'anima
contemplativa, davanti a questo spettacolo. E continuava: Chi non ricambierà
amore per amore? Chi non abbraccerà un Cuore così puro? Noi, che siamo di
carne, pagheremo amore con amore, abbracceremo il nostro ferito, al quale gli
empi hanno trapassato mani e piedi, il costato e il Cuore. Chiediamogli che si
degni di legare il nostro cuore con il vincolo del suo amore e di ferirlo con
la lancia, perché è ancora duro e impenitente.
Sono pensieri, affetti, espressioni che da sempre le anime innamorate hanno
rivolto a Gesù. Ma per intendere questo linguaggio, per capire veramente il
cuore umano, il Cuore di Cristo e l'amore di Dio, occorrono fede e umiltà.
Frutto di fede e di umiltà sono le parole universalmente famose che
sant'Agostino ci ha lasciato: Ci hai creato, Signore, per te, e il nostro cuore
è inquieto finché non riposa in te.
Quando si trascura l'umiltà, l'uomo pretende di appropriarsi di Dio, e non
nella maniera divina che Cristo ha reso possibile dicendo: Prendete e mangiate,
questo è il mio corpo; bensì cercando di ridurre la grandezza divina ai limiti
umani. La ragione umana, la ragione fredda e cieca che non è l'intelligenza che
procede dalla fede, e nemmeno la retta intelligenza di chi sa gustare e amare
le cose, si trasforma nell'insensatezza di chi sottomette ogni cosa alle sue
povere esperienze banali, quelle che rimpiccioliscono la verità sovrumana e
ricoprono il cuore di una crosta insensibile alle mozioni dello Spirito Santo.
La nostra povera intelligenza si smarrirebbe se non ci venisse incontro il
potere misericordioso di Dio che rompe le frontiere della nostra miseria: Vi
darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò da voi
il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E l'anima ritrova la luce, si
riempie di gioia, davanti alle promesse della Sacra Scrittura. (continua)
Giugno 2025
Nella viva luce della Pasqua il Signore ha voluto chiamare a Sé Papa Francesco. Per diverse settimane eravamo stati in apprensione per la sua salute, pregando per lui e per la Chiesa e, quando sembrava ormai inatteso, è giunto il momento in cui la sua vita terrena si è conclusa.
Nella morte di ogni persona cara, insieme al dolore del distacco, brillano come luci, come chiamate che ci interpellano, le realtà di bene che si sono manifestate nella sua vita. Così sta avvenendo, in modo particolare, per Papa Francesco: in questi giorni è emersa alla nostra mente e al nostro cuore la ricca eredità della sua testimonianza e gli appelli che lo Spirito Santo ci ha rivolto attraverso di lui per il nostro cammino di cristiani.
È un compito che vogliamo portare avanti nella preghiera, nella riflessione alla luce dello Spirito Santo, per ringraziare il Signore e mettere a frutto nella nostra vita i doni ricevuti mentre, allo stesso tempo, preghiamo per lui e per il cammino che attende la Chiesa con il nuovo successore di Pietro che verrà eletto nei prossimi giorni.
In quest’ultimo scorcio del suo pontificato, tra i motivi ricorrenti che hanno caratterizzato l’insegnamento di Papa Francesco a partire dall’indizione del Giubileo, c’è quello della Speranza:" «Spes non confundit », «la speranza non delude» (Rm 5,5) – ci diceva nella Bolla di indizione del Giubileo. "Per tutti, possa essere un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù, «porta» di salvezza (cfr. Gv 10,7.9); con Lui, che la Chiesa ha la missione di annunciare sempre, ovunque e a tutti quale «nostra speranza» (1Tm 1,1). (…). La speranza, infatti, nasce dall’amore e si fonda sull’amore che scaturisce dal Cuore di Gesù trafitto sulla croce”.
Secondo i disegni divini la chiamata di Papa Francesco a crescere nella Speranza, in questo tempo di preparazione alla Pasqua, si è intrecciata con l’esperienza della malattia che lo ha preparato all’incontro con Gesù risorto, la Pasqua eterna della sua vita.
Nell’omelia della Domenica delle Palme, Papa Francesco ha condotto il nostro sguardo su Simone di Cirene “Mentre guardiamo, tra la folla, i volti dei soldati e le lacrime delle donne, la nostra attenzione viene attirata da uno sconosciuto, il cui nome entra nel Vangelo all’improvviso: Simone di Cirene. Quest’uomo viene preso dai soldati, che «gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù»” (…) egli si trova a partecipare in prima persona alla passione del Signore. La croce di Gesù diventa la croce di Simone”.
Nella singolare condizione di Simone Papa Francesco ci aiuta a scoprire quella nella quale si vengono a trovare tanti uomini e donne chiamati ad affrontare la sofferenza che la vita carica sulle loro spalle. Insieme a Simone possiamo riflettere sul mistero della croce che egli seppe abbracciare.
“Se ricordiamo che cosa ha fatto Simone per Gesù, ricordiamo pure che cosa ha fatto Gesù per Simone – come per me, per te, per ognuno di noi –: ha redento il mondo. La croce di legno, che il Cireneo sopporta, è quella di Cristo, che porta il peccato di tutti gli uomini. Lo porta per amore nostro, in obbedienza al Padre (cfr Lc 22,42), soffrendo con noi e per noi. È proprio questo il modo, inatteso e sconvolgente, col quale il Cireneo viene coinvolto nella storia della salvezza, dove nessuno è straniero, nessuno è estraneo. (…)
Vediamo il Signore nei loro volti, straziati dalla guerra e dalla miseria? Davanti all’atroce ingiustizia del male, portare la croce di Cristo non è mai vano, anzi, è la maniera più concreta di condividere il suo amore salvifico".
La crescita nella Speranza, per noi sacerdoti, si sviluppa altresì attraverso una rinnovata fede in quella singolare partecipazione alla missione messianica di Cristo, al suo Sacerdozio, a cui siamo stati chiamati. Nell’Omelia della Messa crismale, commentando il passo del Vangelo: “entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo“ (Lc 4,16-17) Papa Francesco ci aiuta a leggere: “In Gesù si apre il libro della storia e lo si può leggere. Anche noi sacerdoti abbiamo una storia: rinnovando il Giovedì Santo le promesse dell’Ordinazione, confessiamo di poterla leggere soltanto in Gesù di Nazaret. «Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue» (Ap 1,5) apre anche il rotolo della nostra vita e ci insegna a trovare i passi che ne rivelano il senso e la missione. Quando lasciamo che sia Lui a istruirci, il nostro diventa un ministero di speranza, perché in ognuna delle nostre storie Dio apre un giubileo, cioè un tempo e un’oasi di grazia, (…)È un popolo intero a trovare ristoro, quando il giubileo inizia nella nostra vita: (…) in quella prossimità quotidiana del prete alla sua gente in cui le profezie di giustizia e di pace si adempiono.
Se Gesù nel rotolo ha trovato questo passo, oggi lo continua a leggere nella biografia di ognuno di noi. Primariamente perché, fino all’ultimo giorno, è sempre Lui a evangelizzarci, a liberarci dalle prigioni, ad aprirci gli occhi, a sollevare i pesi caricati sulle nostre spalle. E poi perché, chiamandoci alla sua missione e inserendoci sacramentalmente nella sua vita, Egli libera anche altri attraverso di noi. In genere, senza che ce ne accorgiamo. Il nostro sacerdozio diventa un ministero giubilare, come il suo”.
La rinnovata apertura alla grazia che ci identifica con Cristo Messia e sacerdote ci fa rivivere nella vita di ogni giorno, il mistero pasquale di morte e risurrezione e ci trasforma in annunciatori di una Speranza che germoglia e cresce a poco a poco nella nostra vita: la luce lentamente risplende anche se siamo nelle tenebre; la speranza di una vita nuova e di un mondo finalmente liberato ci attende; un nuovo inizio può sorprenderci benché a volte ci sembri impossibile, perché Cristo ha vinto la morte (…)
La forza e la fecondità della Speranza crescono in noi al passo del nostro immergerci personalmente nel mistero della morte e risurrezione di Cristo. “Fratelli e sorelle, ecco la speranza più grande della nostra vita: possiamo vivere questa esistenza povera, fragile e ferita aggrappati a Cristo, perché Lui ha vinto la morte, vince le nostre oscurità e vincerà le tenebre del mondo, per farci vivere con Lui nella gioia, per sempre (…). Il Giubileo ci chiama a rinnovare in noi il dono di questa speranza, a immergere in essa le nostre sofferenze e le nostre inquietudini, a contagiarne coloro che incontriamo sul cammino, ad affidare a questa speranza il futuro della nostra vita e il destino dell’umanità (…)” (Omelia della Messa del giorno di Pasqua 2025).
“L’amore ha vinto l’odio. La luce ha vinto le tenebre. La verità ha vinto la menzogna. Il perdono ha vinto la vendetta. Il male non è scomparso dalla nostra storia, rimarrà fino alla fine, ma non ha più il dominio, non ha più potere su chi accoglie la grazia di questo giorno….” (Messaggio «urbi et orbi» - Pasqua 2025).
Papa Francesco ci ha lasciati spendendo fino alla fine la sua paternità per condurci sulle vie della “Speranza che non delude”. Mentre preghiamo per lui e per la Chiesa intera - e già per colui che lo Spirito Santo chiamerà a succedergli sulla Cattedra di Pietro - raccogliamo, da buoni figli, le luci forti e attraenti che ci ha donato e gli inviti accorati che ci ha rivolto per camminare personalmente ed esercitare il nostro ministero sacerdotale “al passo della Speranza”. “Sì, la risurrezione di Gesù è il fondamento della speranza: a partire da questo avvenimento, sperare non è più un’illusione. No. Grazie a Cristo crocifisso e risorto, la speranza non delude! Spes non confundit! (cfr Rm 5,5). E non è una speranza evasiva, ma impegnativa; non è alienante, ma responsabilizzante. Quanti sperano in Dio pongono le loro fragili mani nella sua mano grande e forte, si lasciano rialzare e si mettono in cammino: insieme con Gesù risorto diventano pellegrini di speranza, testimoni della vittoria dell’Amore, della potenza disarmata della Vita" (Messaggio «urbi et orbi» - Pasqua 2025).
Qualche giorno fa, durante la celebrazione della santa Messa, mi sono soffermato un istante sulle parole del salmo che la liturgia proponeva come antifona di Comunione: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla» [Sal 22, 1. Antifona alla Comunione del sabato della IV settimana di Quaresima]. Questa invocazione mi aveva riportato alla memoria il versetto di un altro salmo che si recitava un tempo nella cerimonia della prima tonsura: «Il Signore è la parte della mia eredità» [Sal 15, 5]. Cristo stesso si mette infatti nelle mani dei sacerdoti, che diventano così «dispensatori dei misteri» — dei portenti — «del Signore» [1 Cor 4, 1]. (…)
Il sacerdozio porta a servire Dio in uno stato che non è, in sé stesso, migliore o peggiore di altri: è diverso. Tuttavia, la vocazione sacerdotale si presenta rivestita di una dignità e di una grandezza tali che null'altro sulla terra può superare. Santa Caterina da Siena pone sulle labbra di Gesù queste parole: «Io non volevo che la riverenzia verso di loro diminuisse... perché ogni riverenzia che si fa a loro, non si fa a loro, ma a me, per la virtù del Sangue che io l'ho dato a ministrare. Unde, se non fusse questo, tanta riverenzia avareste a loro quanta agli altri uomini del mondo, e non più... E così non debbono essere offesi, però che, offendendo loro, offendono me e non loro. E già l'ho vetato, e detto che i miei Cristi non voglio che sieno toccati per le loro mani» [Santa Caterina da Siena, Il Dialogo della divina Provvidenza, cap. 116; cfr Sal 104, 15].
Taluni si affannano a cercare quella che chiamano l'identità del sacerdote. Quanto sono chiare le parole della santa di Siena! Qual è l'identità del sacerdote? Quella di Cristo. Tutti noi cristiani possiamo e dobbiamo essere non soltanto alter Christus, ma anche ipse Christus: un altro Cristo; lo stesso Cristo! Ma il sacerdote lo è in modo immediato, in forma sacramentale.
«Per realizzare un'opera così grande» — quella della Redenzione — «Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel Sacrificio della Messa sia nella persona del ministro, "Egli che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora sé stesso per il ministero dei sacerdoti", sia soprattutto sotto le specie eucaristiche» [Concilio Vaticano II, cost. Sacrosanctum Concilium, 7; cfr Concilio di Trento, doctr. De ss. Missae sacrif., cap. 2; DS 1743]. Per mezzo del Sacramento dell'Ordine, il sacerdote è reso effettivamente idoneo a prestare a Gesù nostro Signore la voce, le mani e tutto il suo essere; è Gesù che, nella santa Messa, con le parole della Consacrazione, cambia la sostanza del pane e del vino nel suo Corpo, nella sua Anima, nel suo Sangue e nella sua Divinità.
È questo il fondamento dell'incomparabile dignità del sacerdote. È una grandezza ricevuta in prestito, compatibile con la mia pochezza. Prego Dio nostro Signore che conceda a tutti noi sacerdoti la grazia di compiere santamente le cose sante, di rispecchiare con la nostra stessa vita lo splendore delle grandezze del Signore. «Noi che celebriamo i misteri della Passione del Signore, dobbiamo imitare quello che facciamo. E allora l'ostia occuperà il nostro posto al cospetto di Dio, perché noi stessi ci facciamo ostia» [S. Gregorio Magno, Dialoghi, 4, 59].
Qualora vi imbattiate in un sacerdote che per il suo contegno non sembra vivere secondo il Vangelo — non sta a voi giudicarlo, lo giudica Dio — sappiate che se celebra validamente la santa Messa, con l'intenzione di consacrare, il Signore non si rifiuta di scendere nelle sue mani, ancorché siano indegne. È possibile una donazione maggiore, un annientamento più grande? Più che a Betlemme, più che sul Calvario. Perché? Perché Gesù Cristo ha il cuore angosciato dall'ansia di redenzione, perché non vuole che qualcuno possa dire di non essere stato chiamato, perché Egli stesso va incontro a coloro che non lo cercano.
Egli è Amore! E non c'è altra spiegazione. Quanto sono insufficienti le parole per parlare dell'Amore di Cristo! Egli si adatta a tutto, accetta tutto, si espone a tutto — ai sacrilegi, alle bestemmie, alla fredda indifferenza di tanti — pur di offrire, anche a un solo uomo, l'occasione di scoprire i palpiti del suo Cuore ardente, nel suo petto ferito.
L'identità del sacerdote è questa: essere strumento immediato e quotidiano della grazia salvifica che Cristo ha meritato per noi. Quando si comprende questo principio, quando lo si medita nell'attivo silenzio della preghiera, come possiamo considerare il sacerdozio una rinuncia? È un guadagno incalcolabile. Maria Santissima, nostra Madre, la più santa delle creature — più di Lei solo Dio — trasse una sola volta Gesù al mondo; i sacerdoti lo portano su questa terra, al nostro corpo, alla nostra anima, tutti i giorni: e Gesù viene, per nutrirci, per vivificarci, per essere fin da ora pegno della vita futura. (…)
È opportuno ricordare, con caparbia insistenza, che tutti i sacerdoti — sia noi peccatori che quelli che sono santi — quando celebrano la santa Messa non sono più sé stessi. Sono Cristo che rinnova sull'Altare il suo divino Sacrificio del Calvario. «Nel mistero del Sacrificio Eucaristico, in cui i sacerdoti svolgono la loro funzione principale, viene esercitata ininterrottamente l'opera della nostra Redenzione, e quindi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale è sempre un atto di Cristo e della sua Chiesa, anche quando non è possibile che vi assistano i fedeli» [Presbyterorum ordinis, 13].
Il Concilio di Trento insegna che «nel divino Sacrificio che si realizza nella Messa, è contenuto e incruentemente immolato quello stesso Cristo che una sola volta ha offerto sé stesso cruentemente sull'altare della Croce... Una sola e la stessa è infatti la vittima; colui che ora viene offerto per mezzo del ministero dei sacerdoti è lo stesso che allora si offrì sulla Croce, essendo diverso soltanto il modo di offrirsi» [De ss. Missae sacr., cap. 2].
La presenza o l'assenza dei fedeli alla santa Messa non modifica in nulla questa verità di fede. Quando celebro circondato dal popolo, ne provo piacere, ma non ho bisogno di considerarmi presidente di un'assemblea. Da un lato, sono un fedele come gli altri; ma, dall'altro, sono anche e soprattutto Cristo sull'Altare. Rinnovo incruentemente il divino Sacrificio del Calvario e consacro in persona Christi, perché rappresento realmente Gesù Cristo, gli do in prestito il mio corpo, la mia voce, le mie mani, il mio povero cuore tanto spesso macchiato e bisognoso di essere da Lui purificato.
Quando celebro la santa Messa con la sola partecipazione di colui che mi aiuta, anche allora il popolo è presente. Sento accanto a me tutti i cattolici, tutti i credenti e anche quelli che non credono. Sono presenti tutte le creature di Dio — la terra, il cielo, il mare, gli animali e le piante —: è la Creazione intera che dà gloria al Signore.
Ma più ancora mi unisco in sommo grado — dirò con le parole del Concilio Vaticano II — al culto della Chiesa celeste, comunicando con essa e venerando la memoria soprattutto della gloriosa sempre Vergine Maria, del beato Giuseppe e dei beati apostoli e martiri, e di tutti i santi [Cfr Lumen gentium, 50].
Chiedo a tutti i fedeli che preghino molto per noi sacerdoti perché sappiamo compiere santamente il santo Sacrificio. Chiedo loro di dimostrare un amore così delicato alla santa Messa, da spingerci a celebrarla con dignità — con eleganza — umana e soprannaturale; con decoro nei paramenti e negli oggetti destinati al culto, con devozione, senza fretta.
Perché questa fretta? Gli innamorati hanno forse fretta di salutarsi dopo un incontro? Sembra che si lascino, ma non se ne vanno; ritornano una volta e un'altra, e si dicono parole comuni come se le scoprissero solo allora... Non abbiate timore di riferire alle cose di Dio gli esempi suggeriti dall'amore nobile e puro degli uomini. Se amiamo il Signore con il nostro cuore di carne — non abbiamo che questo — non avremo fretta di terminare questo incontro, questo appuntamento d'amore con Lui.
Alcuni procedono con calma, né gli importa di prolungare fino alla stanchezza letture, monizioni e avvisi. Ma quando giungono al momento principale della santa Messa, al Sacrificio propriamente detto, diventano precipitosi e contribuiscono a far sì che i fedeli non adorino con devozione Cristo Sacerdote e Vittima, né imparino a rendergli grazie — con calma, senza precipitazione — per essere voluto venire ancora una volta in mezzo a noi.
Tutti gli affetti e i bisogni di un cuore cristiano trovano nella santa Messa il loro vero alveo: quello che, per mezzo di Cristo, conduce al Padre nello Spirito Santo. Il sacerdote deve porre ogni cura perché tutti lo sappiano e lo vivano. Non c'è, ordinariamente, nessuna attività che possa essere anteposta a quella di far conoscere, amare e venerare la Sacra Eucaristia. (…)
Quando un sacerdote vive la santa Messa come si deve — adorando, espiando, impetrando, rendendo grazie, identificandosi con Cristo — e insegna agli altri a fare del Sacrificio dell'Altare il centro e la radice della vita cristiana, dimostra realmente la grandezza incomparabile della sua vocazione, e cioè quel carattere che porta impresso e che non perderà per tutta l'eternità.
Tempo di misericordia, tempo di conversione
“Tu ami tutte le tue creature, Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato; tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio” (Liturgia del Mercoledì delle Ceneri). Si rinnova un tempo di tenerezza paterna del nostro Dio che si fa incontro ai suoi figli per portarli più dentro alla sua stessa vita, aiutandoli ad allontanare da sé ciò che vi si oppone o che la ostacola. Per questo la grazia della misericordia divina ci chiama alla conversione. “Il Signore non si accontenta di condividere: chiede tutto. E avvicinarsi un po' di più a Lui vuol dire essere disposti a una nuova conversione” (S. Josemaría Escrivá - È Gesù che passa, n.58). È il mistero della gelosia divina che non si riferisce a una desiderio di possesso, ma alla volontà di salvarci e di guidare la nostra vita alla sua pienezza, alla vera gioia.
La grazia della Quaresima si fa particolarmente intensa in quest’anno giubilare. Il Giubileo, infatti, è la manifestazione della grande misericordia di Dio per il suo popolo, testimonianza di quanto Egli ci ama e perciò rivelazione di quanto merita di essere amato: in questa luce il Giubileo è tempo nel quale, toccati dalla misericordia del Padre, siamo invitati ad aprirci a una profonda conversione al Suo amore. “Per tutti, possa essere un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù, «porta» di salvezza” (Papa Francesco - Spes non confundit), dal quale scaturisca una più profonda esigenza di amore: “il seme divino della carità, che Dio ha posto nelle nostre anime, aspira a crescere, a manifestarsi in opere e a produrre frutti che in ogni momento corrispondano ai desideri del Signore" (S. Josemaría Escrivá - È Gesù che passa, n.58).
L’invito alla conversione risuona con particolare pregnanza nel cuore dei pastori. Guidare le figlie e i figli di Dio sulle strade della misericordia divina e della conversione per una più piena partecipazione alla vita della grazia, chiede a loro per primi una piena disponibilità di ascolto dello Spirito, in un rinnovato incontro personale col Signore crocifisso e risorto che muova alla maturazione di una nuovo cambiamento, un nuovo passo nel cammino della propria santificazione. La volontà di corrispondenza alla grazia si manifesterà, e prenderà corpo, nel percorrere con umile determinazione il cammino quaresimale della preghiera, della penitenza e dell’esercizio della carità. “Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericordia, sono una cosa sola, e ricevono vita l'una dall'altra” (S. Pietro Crisologo - Discorsi).
In primo luogo, la preghiera: “quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto”. Raccogliersi nell’intimità con Dio in una preghiera piena di sincerità e disponibilità. “.. io vorrei per tutti noi la vera orazione dei figli di Dio, - ci esorta S. Josemaria Escrivá - non la verbosità degli ipocriti a cui è rivolto l'ammonimento di Gesù: Non chiunque mi dice: «Signore, Signore!» entrerà nel regno dei cieli [Mt 7, 21]. Coloro che sono mossi da ipocrisia potranno forse ottenere il rumore dell'orazione - scriveva Sant'Agostino - ma non la sua voce, perché in essi manca la vita [Sant'Agostino, Enarrationes in Psalmos, 139, 10], perché manca la disposizione di compiere la volontà del Padre. Il nostro invocare il Signore vada dunque unito al desiderio efficace di tradurre in realtà le mozioni interiori che lo Spirito Santo suscita nella nostra anima” (S. Josemaría Escrivá - Amici di Dio, 243).
È un richiamo a superare la routine nella quale talora la nostra preghiera perde il contatto vivo e personale con Dio e perciò non ha una vera incidenza sulla nostra vita. «Chiediamoci, magari dopo tanti anni di ministero, che cos’è oggi per noi, che cos’è oggi per me, pregare. Forse la forza dell’abitudine e una certa ritualità ci hanno portati a credere che la preghiera non trasformi l’uomo e la storia. Invece pregare è trasformare la realtà. È una missione attiva, un’intercessione continua. Non è distanza dal mondo, ma cambiamento del mondo. Pregare è portare il palpito della cronaca a Dio perché il suo sguardo si spalanchi sulla storia. Cos’è per noi pregare? E ci farà bene oggi domandarci se la preghiera ci immerge in questa trasformazione; se getta una luce nuova sulle persone e trasfigura le situazioni. Perché se la preghiera è viva, “scardina dentro”, ravviva il fuoco della missione, riaccende la gioia, provoca continuamente a lasciarci inquietare dal grido sofferente del mondo» (Francesco, Omelia, 12 marzo 2022).
Alla preghiera si uniscono la penitenza e la mortificazione: “La vocazione cristiana è vocazione di sacrificio, di penitenza, di espiazione. Dobbiamo riparare per i nostri peccati (…) e per tutti i peccati degli uomini. (…) La mortificazione è il sale della nostra vita. E la migliore mortificazione è quella che - in piccole cose, lungo tutta la giornata - combatte contro la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Si tratta di mortificazioni che non mortificano gli altri, che ci rendono più garbati, più comprensivi, più aperti con tutti” (S. Josemaría Escrivá - È Gesù che passa, n.9).
Il frutto genuino di un autentico cammino di preghiera e di sacrificio si manifesterà nella crescita della carità. “Chi nel domandare desidera di essere esaudito, esaudisca chi gli rivolge domanda. Chi vuol trovare aperto verso di sé il cuore di Dio non chiuda il suo a chi lo supplica. (…) Ascolti chi ha fame, se vuole che Dio gradisca il suo digiuno. Abbia compassione, chi spera compassione. Chi domanda pietà, la eserciti. Chi vuole che gli sia concesso un dono, apra la sua mano agli altri” (S. Pietro Crisologo - Discorsi).
In quest’anno giubilare e in particolare nel tempo di Quaresima, una manifestazione particolare della carità pastorale dei presbiteri è quella di saper dispensare con generosità la grazia del Sacramento della Riconciliazione, invitando i fedeli ad abbeverarsi a questa sorgente di Speranza, “insostituibile punto di partenza di un reale cammino di conversione” (Papa Francesco - Spes non confundit). Per questo “nelle Chiese particolari si curi in modo speciale la preparazione dei sacerdoti e dei fedeli alle Confessioni e l’accessibilità al sacramento nella forma individuale" (ibidem).
Un impegno pastorale che talora può risultare faticoso per quanti sono spesso da soli alla guida di una comunità parrocchiale, ma che sarà feconda per il cammino di rinnovamento e di crescita spirituale dei fedeli affidatici. “… a immagine del Buon Pastore, il prete è uomo di misericordia e di compassione, vicino alla sua gente e servitore di tutti … Chiunque si trovi ferito nella propria vita, in qualsiasi modo, può trovare in lui attenzione e ascolto… In particolare il prete dimostra viscere di misericordia nell’amministrare il sacramento della Riconciliazione; lo dimostra in tutto il suo atteggiamento, nel modo di accogliere, di ascoltare, di consigliare, di assolvere… Ma questo deriva da come lui stesso vive il sacramento in prima persona, da come si lascia abbracciare da Dio Padre nella Confessione, e rimane dentro questo abbraccio… Se uno vive questo su di sé, nel proprio cuore, può anche donarlo agli altri nel ministero”. (Papa Francesco - Ai parroci di Roma 6 marzo 2014)
Come “ buoni pastori” siamo chiamati a precedere il gregge in un rinnovato amore e fedeltà nell’accostarci personalmente con frequenza al Sacramento della Riconciliazione riscoprendone i frutti copiosi per il nostro cammino di santificazione.“Lasciamoci fin d’ora attrarre dalla speranza e permettiamo che attraverso di noi diventi contagiosa per quanti la desiderano. Possa la nostra vita dire loro: «Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore» (Sal 27,14).(Papa Francesco – Spes non confundit)
Tuttavia il desiderio del cristiano di penetrare il senso profondo dell’Incarnazione lo spinge alla contemplazione attenta di quella crescita di Gesù “ in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini”(Lc 2,52). Lo sguardo interiore va percorrendo quei tanti anni in cui Gesù visse a Nazareth, con Maria e Giuseppe, cercando di cogliere il mistero del “Dio con noi”: delle situazioni abituali dell’esistenza umana che vengono illuminate e trasformate dall'umanità di Cristo. Ad uno sguardo superficiale si sarebbe portati a considerarli “anni oscuri” – come talora sono stati chiamati - per l’assenza di una narrazione specifica nei Vangeli. Nella luce dello Spirito invece, essi diventano “luminosi come la luce del sole” nel rivelare lo svolgersi del cammino della redenzione e della santificazione dell’esistenza umana nei percorsi della vita ordinaria.
"Gesù, che cresce e vive come uno di noi, ci rivela che l'esistenza umana, con le sue situazioni più semplici e comuni, ha un senso divino. (…) Per sei lustri Gesù non fu che questo: fabri filius, il figlio dell'artigiano. (…) la sua vita era stata la vita comune della gente della sua terra. (…) era noto come faber, filius Mariae, l'artigiano, figlio di Maria" (S. Josemaría Escrivá, È Gesù che passa, n.14-15).
I gesti, i pensieri, i desideri, le azioni, i compiti che si ripetono nell’esistenza quotidiana di tanti milioni di uomini e donne sulla faccia della terra nel condividere la vita famigliare, nel portare avanti un lavoro, nel nutrirsi, nel riposare, nell’intessere relazioni quotidiane con gli altri, ecc. sembrano realtà ovvie, necessarie, che consideriamo spesso senza valore, quasi anonime, riguardo al rapporto con Dio che sembrerebbe concentrarsi invece nella vita sacramentale e nei momenti esclusivamente dedicati alla preghiera. Eppure, dopo l’Incarnazione del Verbo, per il vivere quotidiano di Cristo a Nazareth, tutte le realtà della vita ordinaria si aprono a un significato divino. Vivendo quegli stessi gesti e compiti, Gesù esprimeva continuamente, attraverso di essi, la sua relazione filiale con il Padre: una realtà di amore, di unione, di fedele compimento della Sua volontà. Ogni suo gesto è una scintilla d’amore che intende accendere il fuoco dell’amore di Dio ai gesti della vita ordinaria di ogni uomo che vive la vicenda di questo mondo: “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! " (Lc 12,49)
“Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio” (Papa Francesco, Gaudete et exultate, n.7).
Durante quei trent’anni di vita a Nazareth, Gesù ha depositato nei gesti e nelle piccole azioni della vita quotidiana, qualcosa di santo. “Sappiatelo bene: c'è un qualcosa di santo, di divino, nascosto nelle situazioni più comuni, qualcosa che tocca a ognuno di voi scoprire” (S. Josemaría Escrivá, Colloqui n.114).
La vita ordinaria nel mondo diviene luogo dove Dio abita e dove ci attende per incontrarci, per portare avanti il dialogo con le sue creature, con i suoi figli e le sue figlie. Lì Dio Padre vuole che scopriamo la realtà del suo amore e che riconosciamo in quei compiti, in quei piccoli gesti, in quelle relazioni, la chiamata a dargli, come Gesù – e come Maria e Giuseppe - la nostra risposta di amore: con la premura, la diligenza, la carità, lo spirito di servizio, la laboriosità, la rettitudine che trasformano ogni gesto in un dono di amore a Lui. Le realtà della vita ordinaria si rivelano, in tal modo, come i piccoli passi del cammino di santificazione – di identificazione con Cristo – al quale è chiamato ogni battezzato. Seguendo le orme della vita quotidiana di Gesù a Nazareth - e con lui, la vita di Maria e di Giuseppe - la prosa quotidiana, si trasforma in poesia (cfr. S. Josemaría Escrivá, Colloqui n.116). Allora acquistano valore le piccole cose che spesso disprezziamo, protesi alla ricerca delle cose grandi: quelle realtà in cui poter riconoscere le nostre capacità o il successo che raccogliamo presso gli altri, quelle più grandi emozioni che sembrano poter colmare il senso della nostra esistenza.
Seguendo i sentieri tracciati da Gesù nella vita quotidiana di Nazareth, va crescendo nel cristiano una profonda unità di vita che allontana dal pericolo della doppia vita: “da una parte, la vita interiore, la vita di relazione con Dio; dall'altra, come una cosa diversa e separata, la vita famigliare, professionale e sociale, fatta tutta di piccole realtà terrene”, ci dice San Josemaría, che aggiunge: “No, figli miei! Non ci può essere una doppia vita, non possiamo essere come degli schizofrenici, se vogliamo essere cristiani: vi è una sola vita, fatta di carne e di spirito, ed è questa che dev’essere - nell'anima e nel corpo - santa e piena di Dio: questo Dio invisibile lo troviamo nelle cose più visibili e materiali” (Ib.).
Fare esperienza nelle piccole cose della vita ordinaria, di quanto Dio ci ama e cercare di dargli la nostra risposta di amore, ci rende sale e luce, annunciatori agli altri dell’amore di Dio.
“È quando incontriamo il Signore che veniamo inondati da quell’amore di cui Lui solo è capace. Allora, «quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi», la vita cambia e «raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 8). Perché a quel punto l’esigenza di annunciarlo nasce spontanea, diventa irrefrenabile, anche senza parole, con la testimonianza” (Papa Francesco, Discorso 30 novembre 2019).
È dall’incontro continuo con il Signore nella vita ordinaria che si riverbera, su quanti ci avvicinano, la realtà della sua presenza e del suo amore: “L'apostolato, ansia che consuma interiormente il cristiano della strada, non è qualcosa di diverso dal compito di ogni giorno: si confonde col lavoro quotidiano, quando esso è trasformato in occasione di incontro personale con Cristo (…) il panorama diviene vasto e il cuore si riempie di ambizione di servire e di incoercibile desiderio di annunciare a tutte le creature i magnalia Dei [At 2, 11], le cose meravigliose che il Signore opera, quando non glielo impediamo” (S. Josemaría Escrivá, Amici di Dio, n. 264)
Contemplare con assiduità la vita di Gesù a Nazareth ci spinge a intrattenere con Lui un dialogo continuo nella vita ordinaria di ogni giorno, la illumina costantemente e ci muove a realizzare in essa, secondo l’esempio di Gesù, quell’incontro di amore filiale con il Padre che ci santifica e ci rende per gli altri luce che illumina, sale che dà sapore; ci trasforma in seminatori di pace e di gioia.
Il Verbo di Dio fatto uomo, che di nuovo attendiamo nella grazia di questo Natale, non venne ad operare una “salvezza“ che soltanto restituisse all’uomo la sua condizione di mera creatura liberata dal peccato e dalle sue conseguenze, ma “ discese dal Cielo” per chiamare gli uomini a “diventare figli di Dio” (Gv 1, 12), “consorti della natura divina” (2 Pt 1,4).
Negli anni della sua predicazione Gesù manifestò a poco a poco ai suoi questo disegno del Padre, a mano a mano che rivelò la sua condizione di Figlio unigenito del Padre che è nei Cieli, mentre insegnava ai suoi a comportarsi “alla maniera del Padre”: ”Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36); “amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste” (Mt 5, 44-45), fino a invitarli “Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5, 48). E quando i discepoli gli chiesero di insegnare anche a loro a pregare affermò: “Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli …” (Mt 6,9). Possiamo immaginare che cosa dovette rappresentare per i discepoli di Gesù quella preghiera che li apriva ad una relazione non di servi, ma di figli con l’Onnipotente.
Infine, Gesù volle pregare il Padre affinché
anch’essi potessero condividere con Lui l’intimità con il Padre: “ Padre,
voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché
contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima
della creazione del mondo… perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi
e io in loro” (Gv 17, 24-26).
La celebrazione del Natale è una splendida occasione per aprirci alla grazia della chiamata ad essere e a vivere come figli di Dio. L'accoglienza del Verbo di Dio fatto uomo nella nostra vita può rendersi più consapevole del dono della filiazione divina in Cristo e svilupparne con più forza le virtualità nelle diverse manifestazioni della nostra esistenza cristiana.
La realtà della filiazione divina fu percepita con particolare profondità da San Josemaría Escrivá come fondamento della vita cristiana e della santificazione, per uno speciale dono di Dio, allorché fu chiamato da Dio a promuovere nella vita dei cristiani la coscienza e la corrispondenza alla chiamata universale alla santità: l’identificazione con Cristo, alla quale siamo tutti chiamati, comporta la gioia e la forza di sapersi figli, amati teneramente dal Padre che lo Spirito Santo ci muove a chiamare “abba!”.
La Sacra Scrittura utilizza la categoria
dell’”adozione a figli”: ma la pur necessaria analogia non deve nasconderci la
realtà che, diversamente dall’adozione umana, quella divina in Cristo ci rende
“partecipi della natura divina” ( 2 Pt 1,4). Non siamo “annoverati” o “
considerati” figli di Dio: “Vedete quale grande amore ci ha
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per
questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi
fin d’ora siamo figli di Dio”
(1 Gv, 3, 1-2). Siamo davvero figli di Dio per la grazia che ci viene
donata nella partecipazione alla
relazione unica che Cristo ha con Dio Padre: siamo figli di Dio in Cristo. L’incorporazione a Cristo,
operata dal Battesimo, è una vera generazione spirituale operata in noi
dall’azione dello Spirito Santo: e questo richiede da noi docilità alla grazia:
“Se siamo docili allo Spirito Santo, l'immagine di Cristo verrà a formarsi
sempre più nitidamente in noi, e in questo modo saremo sempre più vicini a Dio
Padre. Sono infatti coloro che sono
guidati dallo Spirito di Dio, i veri figli di Dio. Se ci lasciamo
guidare da questo principio di vita presente in noi, la nostra vitalità
spirituale si svilupperà sempre più, e noi ci abbandoneremo nelle mani di Dio
nostro Padre con la stessa spontaneità e con la stessa fiducia con cui il
bambino si getta nelle braccia del Padre. (S. Josemaria Escrivá - È
Gesù che passa, n.135)
Corrispondere all’azione dello Spirito Santo vuol dire, dunque, abbandonare un impegno di vita spirituale e di ministero che si appoggi solo sui “santi doveri” o principalmente sulle nostre forze e lasciarsi guidare dall’impulso della grazia ad una “comunione di desideri”. Nutrire una coscienza attuale della filiazione divina ci fa desiderare di avere i “sentimenti di Cristo”, sentimenti e virtù filiali che ci uniscono affettivamente al Padre. In tal modo le virtù cristiane si sviluppano al passo della pietà filiale a Dio: cioè per una corrispondenza di amore filiale.
“Il Signore,
volendoci suoi figli, ci ha ammessi a vivere nella sua casa, in mezzo al mondo:
ha voluto che fossimo della sua famiglia, che tutte le cose sue fossero nostre
e le nostre sue, … Un figlio di Dio tratta il Signore come Padre. Non con
ossequio servile né con riverenza formale, ma con sincerità e fiducia” (ibidem,
n. 64). Coltivando la “pietà filiale” gli
appuntamenti della preghiera quotidiana non si svolgeranno per un mero dovere,
ma per la forza del desiderio filiale dell’incontro con il Padre, secondo il
sentire di Cristo. In tal modo essi non saranno qualcosa di separato dallo svolgimento dei
compiti ordinari del ministero, ma le sorgenti alle quali nutrire e rinnovare
il nostro desiderio di vivere quei nostri compiti nella comunione filiale con
Dio, nostro Padre. È così che “la
devozione che nasce dalla filiazione divina (…) finisce per informare tutta
l'esistenza: è presente in tutti i pensieri, in tutti i desideri, in tutti gli
affetti. (S. Josemaria Escrivá - Amici di Dio, n. 146).
Ci accompagneranno l’ottimismo soprannaturale e la gioia di saperci amati con
predilezione da nostro Padre Dio, l’ampiezza di orizzonti e la magnanimità, così
come la semplicità che i figli “piccoli” vivono con i loro
genitori: una semplicità che ci porterà a confidare sempre nell'amore del Padre e a rialzarci allorché inciampiamo per “ricominciare”
dall’abbraccio paterno che – come nella parabola evangelica - Dio mai ci nega. Nella
figliolanza divina ci sarà più facile scoprire e vivere il legame della
fraternità con tutti gli uomini. In essa si riaccenderà ogni volta lo zelo
apostolico nel desiderio che si compiano i disegni di nostro Padre Dio che “vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità”
(1 Tim 2,4). La
stessa lotta
alle tentazioni troverà nella figliolanza divina la sorgente della fedeltà: “Vi voglio ribelli, - ci dice S.
Josemaría - liberi da ogni legame, perché vi voglio — Cristo ci vuole! — figli di Dio. Schiavitù o filiazione divina: questo è
il dilemma della nostra vita. O figli di Dio, o schiavi della superbia, della
sensualità, dell'egoismo angoscioso in cui tante anime si dibattono” (ibidem, n.38).
“Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 12A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 13i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati” (Gv 1, 11-13). Maria nostra Madre, figlia di Dio prima di esserne la madre, ci condurrà in questi giorni di Natale ad accogliere in profondità il grande dono che il Verbo di Dio ci porta e a coltivarlo con frutto nella nostra vita.
Si conclude l'anno liturgico e nel Santo Sacrificio
dell'altare rinnoviamo l'offerta, al Padre, della Vittima, Cristo, Re di
santità e di grazia, Re di giustizia, d'amore e di pace, come leggeremo fra
poco nel prefazio. Voi tutti, nel considerare
Vorrei che considerassimo in che modo il Cristo che
abbiamo visto, Bambino adorabile, nascere a Betlemme, è Signore dell'universo.
Da Lui sono stati creati tutti gli esseri del Cielo e della terra; Egli ha
riconciliato al Padre tutte le cose, ha ristabilito la pace tra il Cielo e la
terra per mezzo del sangue sparso sulla croce. Oggi Cristo regna alla destra
del Padre: lo dicono i due angeli in bianche vesti ai discepoli che, attoniti,
guardano le nubi, dopo l'Ascensione del Signore: Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al
cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
Grazie a Lui regnano i re: ma mentre le autorità
umane passano, il regno di Cristo durerà per l'eternità, il suo regno è un
regno eterno e il suo dominio perdura di generazione in generazione. Il
regno di Cristo non è un modo di dire o una figura retorica. Cristo vive, anche
come uomo, con lo stesso corpo che, assunto nell'Incarnazione, risuscitò dopo
la morte di croce e, unito alla sua anima umana, sussiste glorioso nella
persona del Verbo. Cristo, vero Dio e vero Uomo, vive e regna ed è Signore
dell'universo. Soltanto per Lui permane in vita tutto ciò che vive.
Perché, allora, non si manifesta a noi in tutta la
sua gloria? Perché il suo regno, che pure è nel mondo, non è di questo mondo.
Gesù aveva infatti risposto a Pilato: Io sono re; per questo sono nato e per
questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è
dalla verità, ascolta la mia voce. Sbagliavano coloro che si attendevano
dal Messia la manifestazione di un potere temporale visibile, perché il
Regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia
nello Spirito Santo.
Verità e giustizia; pace e gioia nello Spirito Santo.
Questo è il regno di Cristo, è l'azione divina che salva gli uomini e che avrà
compimento quando la storia terminerà e il Signore, seduto sul suo trono
eccelso, verrà a giudicare definitivamente gli uomini.
Quando Gesù intraprende la sua predicazione sulla
terra, non offre un programma politico, ma dice: Convertitevi, perché il
Regno dei cieli è vicino; affida ai suoi discepoli la missione di dare
l'annuncio della buona novella, e insegna loro a pregare per l'avvento del
Regno. Ecco il Regno di Dio e la sua giustizia, una vita santa: ciò che
dobbiamo cercare prima di ogni altra cosa e la sola cosa veramente necessaria.
La salvezza che Gesù Cristo nostro Signore predicava
è un invito rivolto a tutti: Il Regno dei cieli è simile a un re che fece un
banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli
invitati alle nozze. Ecco perché il Signore rivela: Il Regno di Dio è in
mezzo a voi. Nessuno è escluso dalla salvezza, purché si arrenda
liberamente alle esigenze d'amore di Cristo: nascere di nuovo, farsi come i
bambini nella semplicità dello spirito, allontanare il cuore da tutto ciò che
separa da Dio. Gesù chiede opere, e non soltanto parole. Chiede uno sforzo
tenace, perché soltanto chi lotta meriterà l'eredità eterna. La pienezza del
regno - il giudizio definitivo di salvezza o di condanna - non è data quaggiù,
sulla terra. Ora il regno è come una semina, come la crescita del granello di
senape; alla fine sarà come la rete del pescatore dalla quale, trascinata a
riva, saranno estratti e separati, per una sorte diversa, gli operatori di
giustizia e quelli di iniquità. Intanto, finché siamo quaggiù, il regno è
simile al lievito che una donna prese e mescolò con tre misure di farina,
finché tutta la massa ne fu fermentata.
Chi comprende il regno che Cristo propone, sente che vale la pena dare tutto per ottenerlo: è la perla che il mercante acquista vendendo tutto ciò che possiede; è il tesoro trovato nel campo. Il regno dei Cieli è una conquista difficile, e nessuno è sicuro di raggiungerlo; ma la supplica umile di un uomo pentito spalanca le sue porte. Uno dei ladroni crocifissi assieme a Gesù gli rivolge la preghiera: Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso».
Quanto sei grande, Signore e Dio nostro! Tu dai alla
nostra vita il senso soprannaturale e l'efficacia divina. Tu ci fai ripetere,
per l'amore a tuo Figlio, con tutte le forze del nostro essere, anima e corpo: Oportet
illum regnare!, anche se intanto risuona il motivo della nostra fragilità,
perché, lo sai bene, siamo creature - povere creature! - fatte di fango, non
solo ai piedi, ma nel cuore e nella mente. Forti però della tua divina
efficacia, vibreremo soltanto per te.
Cristo deve regnare innanzitutto nella nostra anima.
Ma come risponderemo se ci domandasse: tu, mi lasci regnare dentro di te? Io
gli risponderei che per farlo regnare in me ho un grande bisogno della sua
grazia: soltanto così anche il palpito più nascosto, il sospiro impercettibile,
lo sguardo più insignificante e la parola più banale, perfino la sensazione più
elementare, tutto potrà tradursi in un osanna a Cristo, il mio Re.
Se vogliamo che Cristo regni, dobbiamo essere
coerenti: donargli per prima cosa il cuore. Altrimenti, parlare del regno di
Cristo sarebbe suono vano, senza sostanza cristiana, manifestazione esteriore
di una fede inesistente, utilizzazione fraudolenta del nome di Dio per
accomodamenti umani.
Se Gesù, per regnare nella mia, nella tua anima,
ponesse come condizione di trovare in noi un luogo perfetto, avremmo buon
motivo per disperarci. E invece, non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo Re
viene, seduto sopra un puledro d'asina. Vedete? Gesù accetta di avere per
trono un povero animale. Non so se
capita anche a voi, ma io non mi sento umiliato nel riconoscermi dinanzi al
Signore come un somarello: Sono come un somarello di fronte a te, ma sono
sempre con te, perché tu mi hai preso con la tua destra, tu mi conduci per
la cavezza.
Pensate un po' alle caratteristiche di un somaro, ora
che ne restano così pochi. Non pensate all'animale vecchio e cocciuto, che
sfoga i suoi rancori tirando calci a tradimento, ma all'asinello giovane, dalle
orecchie tese come antenne, austero nel cibo, tenace nel lavoro, che trotta
lieto e sicuro. Vi sono centinaia di animali più belli, più abili, più crudeli.
Ma Cristo, per presentarsi come re al popolo che lo acclamava, ha scelto lui.
Perché Gesù non sa che farsene dell'astuzia calcolatrice, della crudeltà dei
cuori aridi, della bellezza appariscente ma vuota. Il Signore apprezza la gioia
di un cuore giovane, il passo semplice, la voce non manierata, gli occhi
limpidi, l'orecchio attento alla sua parola d'amore. Così regna nell'anima.
Se lasciamo che Cristo regni nella nostra anima, non
saremo mai dei dominatori, ma servitori di tutti gli uomini. Servizio: come mi
piace questa parola! Servire il mio Re e, per Lui, tutti coloro che sono stati
redenti dal suo sangue. Se noi cristiani sapessimo servire! Andiamo dal Signore
e confidiamogli la nostra decisione di voler imparare a servire, perché
soltanto così potremo non solo conoscere e amare Cristo, ma farlo conoscere e
farla amare dagli altri.
Come lo faremo conoscere alle anime? Con l'esempio,
come suoi testimoni, offrendoci a Lui in volontaria servitù in tutte le nostre
opere, perché Egli è il Signore di tutta la nostra vita, perché è l'unica e
definitiva ragione della nostra esistenza. Poi, dopo aver offerto la
testimonianza dell'esempio, saremo idonei a istruire con la parola, con
Per servire gli altri nel nome di Cristo, è
necessario essere molto umani. Se la nostra vita fosse disumana, Dio non vi
edificherebbe nulla, perché di solito non costruisce sul disordine,
sull'egoismo, sulla prepotenza. È necessario comprendere tutti, convivere con
tutti, scusare tutti, perdonare tutti. Non si tratta di dire che è giusto ciò
che non lo è, o che l'offesa a Dio non è offesa a Dio, o che il male è bene.
Però, non risponderemo al male con il male, ma con dottrina chiara e buone
opere, affogando il male nell'abbondanza di bene. Cristo allora regnerà nella
nostra anima e in quella di coloro che ci sono vicini.
C'è chi cerca di costruire la pace nel mondo senza mettere nel suo cuore l'amore di Dio, senza servire le creature per amore di Dio. Come è possibile realizzare una simile missione di pace? La pace di Cristo è quella del suo regno; e il regno di nostro Signore si fonda sul desiderio di santità, sull'umile disponibilità a ricevere la grazia, su una vigorosa opera di giustizia, su una divina effusione d'amore. (continua)
"Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli ” Mt 11,25.
La vita di Gesù si snoda attraverso un continuo colloquio con il Padre che si sviluppa nell'intimo del suo cuore ma che spesso affiora anche alle sue labbra mentre porta avanti la conversazione con gli uomini.
Un aspetto fondamentale della personalità di Cristo, è il suo rapporto di unione con il Padre. Lo scopriamo fin dalla sua vita di ragazzo quando, rispondendo a Maria e Giuseppe che lo ritrovarono nel Tempio, a Gerusalemme disse «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Lc 2,49. In questa risposta Gesù manifesta la profonda comunione con il Padre che Egli viveva già in quei trent’anni di vita a Nazareth: immerso nella vita famigliare, nel lavoro, nella relazioni con la gente, portava avanti un intenso dialogo con suo Padre Dio per conoscere e compiere la sua volontà.
La testimonianza dei Vangeli sugli anni del suo ministero pubblico ci fa scoprire il desiderio vivo che Gesù nutriva di raccogliersi in preghiera e dialogare con il Padre: di buon mattino, come quella volta a Cafarnao (cfr Mc 1,35), all’indomani di una giornata intensa di predicazione e di guarigioni; come anche alla fine della giornata, dopo il grande miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci: allontanandosi dalle folle che “stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo” (Gv 6,15); o passando tutta la notte in preghiera, allorché si disponeva a scegliere i dodici (cfr Lc 6,12). Talora il colloquio con il Padre traboccava come quando, in mezzo alla gente, esclama “«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. ….”(Mt 11,25) oppure quando – prima di operare il miracolo della risurrezione di Lazzaro –, dice: "«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto»" (Gv 11,41-2).
Il nostro cammino alla sequela di Cristo, per l’azione dello Spirito, è un cammino di crescita secondo la Sua vita: la grazia del Battesimo che ci incorpora a Cristo, ci muove alla identificazione con Lui: con i suoi sentimenti, con gli aneliti del suo cuore. In tal modo lo Spirito Santo cerca di far maturare anche in noi quella ricerca di unione con Dio Padre, che ci muova a sviluppare, nel percorso della nostra vita quotidiana, un dialogo ininterrotto con Lui. "E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!»" (Rom 8,15).
Se da un lato sentiamo l'attrazione dello Spirito a coltivare in Cristo questo dialogo filiale con Dio, tuttavia sembra essere ben radicata in noi la convinzione che – tranne i momenti dedicati esclusivamente alla preghiera – sia inevitabile distanziarci da Lui quando siamo immersi nello svolgimento degli svariati compiti a cui ci chiama il nostro ministero. E così non ci sembra possibile intrattenere un dialogo continuo con Dio: pensiamo che esso sia realizzabile solo nella misura in cui mettiamo da parte quelle occupazioni.
L’esperienza spirituale di San Josemaría Escrivá ci mostra invece che l’azione dello Spirito in noi non trova ostacolo nello svolgimento dei compiti ai quali Dio stesso ci ha chiamato. Possiamo dunque scoprire la reale possibilità - anzi una vera chiamata - in forza dell’azione dello Spirito, a vivere sempre, in ogni circostanza, in dialogo con Dio, divenire così “contemplativi in mezzo al mondo” per poter santificare così la vita ordinaria.
"Se siamo in grazia, - dice San Josemaría, rivolgendosi a ogni cristiano - lo Spirito Santo è nel mezzo della nostra anima, dando carattere soprannaturale a tutte le nostre azioni. E, con lo Spirito Santo, ci sono il Padre e il Figlio: la Santissima Trinità, che è un solo Dio. Siamo un tempio della Trinità, e possiamo parlare con Dio semplicemente, senza fare stranezze, (...) Arriviamo lì, nel profondo della nostra anima, per dirgli cosa ci accade: chiedere, adorare, riparare, amare (...). Trattandolo così, con quell'intimità, diventerai un buon figlio di Dio e un suo grande amico: per strada, in piazza, … nella tua vita ordinaria".
L’azione dello Spirito Santo – se corrispondiamo - è capace di trasformare in via di unione con Dio tutta la nostra esistenza: le varie occupazioni del nostro ministero pastorale, i momenti di riposo, l’incontro con gli altri, ecc.: sempre, anche nei momenti umanamente più impegnativi.
Possiamo dire, infatti, che la contemplazione cristiana è frutto dell’amore: - “chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore" (I Gv 4,8) - cioè è frutto dell’azione dello Spirito Santo che ci comunica l’amore soprannaturale, perché “l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rom 5,5) e attraverso di esso contempliamo Dio e i suoi disegni di salvezza.
Questo desiderio di unione con Dio mosso dalla carità si mantiene vivo nel nostro cuore pur quando non possa esprimersi in ragionamenti o considerazioni particolari; nell’azione dello Spirito, attraversa i nostri compiti quotidiani orientandoli a Dio: tutta la vita può essere – con modalità diverse – una continua contemplazione di Dio, in mezzo ai compiti quotidiani.
In questa propsettiva possiamo essere illuminati anche da questa considerazione di San Tommaso D’Aquino: “Quando di due cose una è la ragione dell'altra, l'occupazione dell'anima in una non impedisce né diminuisce l'occupazione nell'altra. E poiché Dio è percepito dai santi come la ragione di tutto ciò che fanno o sanno, la loro occupazione nel percepire le cose sensibili, …. o fare qualsiasi altra cosa, non impedisce loro in alcun modo la contemplazione divina, né viceversa” (S.Th., Suppl., q. 82, a. 3 ad 4).
Se cerchiamo di svolgere tutte le ns azioni, i pensieri, i desideri, secondo l’intenzione di orientarli all’amore di Dio e degli altri, allora vedremo che è possibile contemplarLo in ogni momento.
“Ovunque ci troviamo, in mezzo al rumore della strada e alle preoccupazioni … ci troveremo in una semplice contemplazione filiale, in un dialogo costante con Dio. Perché tutto – persone, cose, compiti – ci offre l'occasione e il tema di un continuo colloquio con il Signore". (S. Josemaría Escrivá, Lettera 11-III-1940, n. 15)
Nel nostro cammino di identificazione con Cristo, guidati dallo Spirito Santo, cercheremo con assiduità, ogni giorno, quei momenti della preghiera che alimentano la nostra vita di unione con Dio, ma se svolgiamo i vari compiti del nostro ministero cercando in essi, ogni volta, una corrispondenza di amore a Lui per il servizio della Chiesa, il nostro dialogo contemplativo sarà sempre più continuo e fecondo di santificazione, perché ci uniremo a Dio proprio “attraverso” il disimpegno quotidiano di quel ministero che Lui stesso ci ha affidato.
Io sono la vite, voi i tralci
Nel riprendere il lavoro di un nuovo anno pastorale desideriamo metterci all’opera con nuovo entusiasmo nel servizio alla Chiesa. La fede nell’azione della grazia che ci sostiene e ci sospinge ci aiuta a vincere le incertezze, i timori, talora provocati dagli ostacoli che si presentano dinanzi a noi.
È un momento opportuno per aprirci ancora di più alle parole che Gesù ripeteva ai suoi discepoli nel Cenacolo: “Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. (…). Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me” (Gv 15, 1, 4).
Le parole del Signore vanno al cuore della questione: siamo coinvolti, con tutta la nostra anima e tutte le capacità umane che Dio ci ha dato nell’opera della Redenzione, ma solo Lui può realizzarla. Da soli, se perdiamo l’unione con Lui, pur con i migliori mezzi umani, ci affaticheremmo invano e non potranno maturare i frutti che il Signore desidera e per i quali ci ha inviati.
L’impegno della nostra umanità al servizio di Cristo - intelligenza, cuore, sensibilità, emozioni, … - talora può farci perdere la percezione viva di essere e di dipendere dall’azione della grazia e può portarci a valutare le cose in funzione dei riscontri terreni del nostro operato: l’entusiasmo generato, i suoi frutti più immediati e tangibili, il successo raccolto. Così pure, al contrario, potremmo lasciarci condizionare e frenare dalle difficoltà che possano sorgere, dalle delusioni, dagli insuccessi.
Cristo ci ripete: "Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla" (Gv 15, 5).
Abbiamo bisogno di maturare sempre di più il nostro reale radicamento in Cristo: per guardare, per valutare le cose secondo il suo sguardo, per vivere secondo il suo cuore, perché il nostro operare si inserisca nel Suo.
Se non cresciamo nella relazione viva e operante con Cristo possono prendere forza in noi delle derive: perdersi nell’impegno organizzativo che il lavoro pastorale comporta, nella consapevolezza delle conoscenze e delle competenze acquisite, nell’immergersi disordinatamente nelle molteplici relazioni. In tal modo la cura della propria vita spirituale può venir meno, la preghiera illanguidirsi e, con essa, la realtà della nostra unione alla vite in modo tale che la stessa premura per la crescita cristiana dei fedeli a noi affidati si indebolisce.
Siamo realmente uniti alla vite, a Cristo, se progrediamo personalmente in questa unione: se – nell’azione della grazia e con la nostra corrispondenza – maturano in noi passi avanti nella santificazione personale. "Il seme divino della carità, che Dio ha posto nelle nostre anime, - ci ricorda S. Josemaría Escrivà - aspira a crescere, a manifestarsi in opere e a produrre frutti che in ogni momento corrispondano ai desideri del Signore” (S. Josemaría Escrivá - Omelie I, n.58).
Come frutto della nostra corrispondenza personale alla santità la nostra vita sacerdotale si trasforma in lievito che fa fermentare tutta la massa. “Per essere lievito - ci ricorda S. Josemaría Escrivá - bisogna essere santi. Il sacerdote: santificarsi e santificare”. E aggiunge: “Il tuo compito, sacerdote, non è solo salvare anime, ma santificarle”. Il ministero sacerdotale di Cristo – e il nostro, in Cristo – è volto, infatti, a condurre ogni uomo e ogni donna alla partecipazione della vita divina, alla santificazione.
La centralità della santificazione personale ci viene inoltre sottolineata dal momento della vita della Chiesa e del mondo che siamo chiamati a vivere e a servire. “L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o, se ascolta i maestri, è perché sono dei testimoni. … In questo contesto si comprende l’importanza di una vita che risuona veramente del Vangelo!” S. Paolo VI - AAS LXVI (1974). E S. Josemaria ci ricorda “ Un segreto. —Un segreto a gran voce: queste crisi mondiali sono crisi di santi…. “ (Cammino n. 301). Lo Spirito Santo, in questo frangente della vita della Chiesa, muove con urgenza alla rigenerazione di una vita cristiana che cerchi in modo attuale la pienezza della vita in Cristo. In modo speciale questo viene chiesto a noi sacerdoti.
Perché si dia una unione efficace del tralcio alla vite, che produca frutti abbondanti di santificazione intorno a noi, è necessario coltivare una vita sacramentale e una vita di preghiera che si accompagnino con la corrispondenza della lotta interiore.
Se la santificazione è progredire nella unione con Gesù, corrispondere alla grazia vuol dire coltivare una relazione viva con la Santissima Eucaristia: nel sacrificio Eucaristico che è centro e culmine della vita della Chiesa e di ogni vita sacerdotale; nel Sacramento che permane nei tabernacoli delle nostre chiese per sostenere e accompagnare il nostro cammino. Vuol dire poi crescere in una relazione personale che si trasformi in un dialogo continuo con il Signore: “Il sentiero che conduce alla santità è un sentiero di orazione” (S. Josemaría Escrivá, Omelie II, 295)
La routine del lavoro quotidiano, anche se ci applichiamo alle “cose di Dio”, può spesso comportare il rischio dell’abitudine e di una certa “spersonalizzazione” della relazione con Dio: certamente ci dirigiamo a Lui guidando la preghiera del popolo di Dio, celebrando i sacramenti, parliamo di Lui nel proclamare e spiegare la Sua Parola, ma potremmo non coltivare l’intimità con Lui - quella intimità che cresce solo nel dialogo personale e costante della preghiera - e così rischiare di perderla.
Per corrispondere in un cammino di santificazione è necessaria, inoltre, la lotta interiore: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso” (Lc 9, 23). Ce lo ricorda anche S. Paolo: “Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù” (Fil 3,12-14).
Il cammino della santificazione è frutto dell’azione della grazia e della nostra corrispondenza nella lotta contro le inclinazioni negative che manifestano in noi, nelle scelte concrete di fedeltà nelle quali mostriamo di voler procedere nell’amore a Dio.
"Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto". Gv 15, 5-7
La corrispondenza personale all’azione della grazia, a “rimanere” in Cristo, sarà garanzia della fecondità del nostro ministero e che quanto ogni giorno chiediamo dalla misericordia di Dio per il bene degli uomini venga esaudito.
“Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare” Mc 6, 30-31.
Qualche giorno prima, Gesù aveva inviato i suoi discepoli con precise indicazioni di sobrietà e di distacco dagli agi materiali: “ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche”(Mc 6, 8-9). Ora, accogliendoli con molta umanità, prende a cuore il l’opportuno riposo dei discepoli dopo le fatiche accumulate nel ministero loro affidato. Il Verbo di Dio, fatto uomo, che visse con pienezza tutte le circostanze della vita terrena per riordinarle alla gloria di Dio, insegna ai suoi – e anche a noi - la convenienza di godere anche di momenti di riposo necessari per rinfrancarsi e riprendere energie. Così, pensando a quel ristoro dei discepoli insieme a Gesù, mentre ci rallegriamo del suo cuore così umano, ci accorgiamo che non c’è situazione che fa parte del giusto e necessario svolgersi della vita umana, che non possa essere vissuta in unione a Cristo e a lode di Dio. Anzi, in questa prospettiva cogliamo che tutto ciò che rettamente fa parte dell’esistenza umana assume il suo più grande valore nell'essere vissuto in unione a Cristo: la gioia e il dolore, il lavoro e la sana distensione, la fatica e il riposo.
La considerazione di questo episodio ci aiuta anche a comprendere come il tempo estivo, con le opportunità che ci offre per un sano riposo dalle nostre fatiche pastorali, è sempre un tempo propizio di santificazione!
In queste settimane, infatti, il ministero pastorale - già accompagnato dalla stanchezza accumulata durante l’anno - è caratterizzato spesso dal clima molto caldo che lo rende più faticoso e, allo stesso tempo, dal fatto che il ritmo di vita della gente – via in vacanza, oppure comunque aperto a programmi di riposo e di svago – comporta una sospensione delle consuete attività formative. Inoltre, anche per noi presbiteri è umano e necessario trovare occasioni, benché brevi, per l’opportuno ristoro e una fruttuosa ricarica fisica e spirituale.
In questo contesto, il ministero pastorale tende a sgranarsi tra momenti più intensi: la celebrazione dell’Eucaristia domenicale, le iniziative con i giovani (grest, campi, ecc,), le feste religiose - in molte regioni più numerose nel tempo estivo - e spazi di tempo anche ampi che bisogna imparare a utilizzare bene.
La stanchezza e l’esigenza di riposare, unita alla minore presenza della abituali opportunità pastorali, potrebbero talora presentarsi come un invito a cercare delle pause anche nel proprio essere preti e nel cammino di santificazione che lo accompagna. Si potrebbe cedere nel ritmo della vita di preghiera, nella centralità della celebrazione eucaristica quotidiana, e potrebbe intiepidirsi lo zelo, la carità pastorale, talora troppo identificata con lo svolgimento di attività organizzate, ora meno presenti. L’esito potrebbe essere un' attenzione eccessiva alla propria comodità, ai propri desideri di benessere e di evasione; talvolta, a piccoli capricci insoddisfatti.
Discernere queste situazioni, secondo la vita e lo spirito di Cristo, può invece portare a scoprire questo tempo come una tappa del nostro cammino di crescita spirituale che sa trarre, dalle sue peculiarità, nuove occasioni di incontro con Dio.
L’umanità di Cristo ci apre strada: Gesù si affaticava percorrendo in lungo e in largo i villaggi della Palestina e cercava l’opportuno ristoro: lo troviamo assetato presso il pozzo di Sicar, che chiede da bere alla Samaritana, ma il suo zelo gli fa trovare in questa occasione un’opportunità di aiutare quella donna a convertirsi. Talvolta approfittava anche di tempi ristretti per riposare un po’ sulla barca come nella traversata del lago: ma all’arrivo sull’altra sponda era sempre pronto ad accogliere le folle che lo cercavano. Gesù sapeva vivere spazi di convivialità e di amicizia (Lazzaro e le sue sorelle, il pranzo con gli amici di Levi, a casa di Simone il fariseo, o di Zaccheo) per aiutare le persone ad aprirsi alla venuta del Regno di Dio; non mancò di condividere e santificare la genuina allegria di una festa di nozze a Cana di Galilea, dove fece il suo primo miracolo perché questa allegria non venisse meno. Tutto questo si intrecciava con i suoi insegnamenti alle folle, le guarigioni, i colloqui personali e, sempre, con l’assidua preghiera al Padre: ciò che alimentava continuamente il suo spirito ed era fonte di discernimento e di zelo.
Dalla vita di Cristo traspare, nella varietà delle situazioni, una profonda “unità di vita”: in tutto si manifestava il suo desiderio di compiere la volontà del Padre, di dargli gloria e di spendersi per il servizio delle anime. Secondo questo stile di Gesù, S. Paolo, potrà dire: "sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio" (1 Cor 10,31)
"Figli miei, lì dove sono gli uomini vostri fratelli, lì dove sono le vostre aspirazioni, il vostro lavoro, lì dove si riversa il vostro amore, quello è il posto del vostro quotidiano incontro con Cristo. È in mezzo alle cose più materiali della terra che ci dobbiamo santificare, servendo Dio e tutti gli uomini. (…) Sappiatelo bene: c'è un qualcosa di santo, di divino, nascosto nelle situazioni più comuni, qualcosa che tocca a ognuno di voi scoprire" (S. Josemaría Escrivá, Colloqui n.113).
Dobbiamo imparare a riconoscere in ogni cosa, in ogni avvenimento, la presenza e l’azione di Dio: il quid divinum, quel richiamo divino, che in essi si manifesta, e che attende una nostra risposta di amore, di unione con Lui, orientando tutto il nostro agire al servizio di Dio e alla Sua Gloria.
È necessario superare quella “doppia vita” che a volte si genera in noi: Non ci può essere una doppia vita, non possiamo essere come degli schizofrenici, se vogliamo essere cristiani: vi è una sola vita, fatta di carne e di spirito, ed è questa che dev'essere - nell'anima e nel corpo - santa e piena di Dio: questo Dio invisibile lo troviamo nelle cose più visibili e materiali.
"Non vi è altra strada, figli miei: o sappiamo trovare il Signore nella nostra vita ordinaria, o non lo troveremo mai. Per questo vi posso dire che la nostra epoca ha bisogno di restituire alla materia e alle situazioni che sembrano più comuni, il loro nobile senso originario, metterle al servizio del Regno di Dio, spiritualizzarle, facendone mezzo e occasione del nostro incontro continuo con Gesù Cristo" (ibi).
Dobbiamo consumare quella distanza che spesso c’è tra “cose o momenti santi”, nei quali cerchiamo la relazione con Dio e la nostra santificazione - e “faccende o momenti profani” nei quali talora ci dimentichiamo di Lui, ci muoviamo in una prospettiva pragmatica, materialistica, secondo logiche mondane.
Nella vita del sacerdote, come in quella di Cristo, c’è la preghiera, la celebrazione dei sacramenti, la passione e la responsabilità di predicare la Parola, ecc, così come c’è la convivialità, il gusto dell’amicizia, la stanchezza e l’esigenza di riposare, ecc.: ma tutto sarà vissuto in “unità di vita”, cercando in ogni cosa, come Cristo, la volontà e la glorificazione del Padre: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera" (Gv 4,34).
È importante fare sempre più nostri i “sentimenti che furono in Cristo Gesù” per vivere sempre secondo il suo cuore sacerdotale, la sua “carità pastorale”.
Il principio interiore, la virtù che anima e guida la vita spirituale del presbitero in quanto configurato a Cristo Capo e Pastore è la carità pastorale, partecipazione della stessa carità pastorale di Gesù Cristo: dono gratuito dello Spirito Santo, e nello stesso tempo compito e appello alla risposta libera e responsabile del presbitero.
"La carità pastorale è quella virtù con la quale noi imitiamo Cristo nella sua donazione di sé e nel suo servizio. (…) La carità pastorale determina il nostro modo di pensare e di agire, il nostro modo di rapportarci alla gente. (…) Questa stessa carità pastorale costituisce il principio interiore e dinamico capace di unificare le molteplici e diverse attività del sacerdote. Grazie ad essa può trovare risposta l'essenziale e permanente esigenza dell'unità tra la vita interiore e le tante azioni e responsabilità del ministero, esigenza quanto mai urgente in un contesto socio-culturale ed ecclesiale fortemente segnato dalla complessità, dalla frammentarietà e dalla dispersività" (Pdv. n.23).
Perché questo avvenga dobbiamo saper coltivare con continuità l’amicizia con Gesù, il rapporto personale con Lui e, insieme con Lui, riposare nella filiazione al Padre: da questa continua conversazione con Cristo verrà l’ordine del cuore che darà ad ogni “passaggio” di questo tempo - impegno pastorale e riposo; fatiche e momenti di condivisione, di distensione, di divertimento, di cura della propria salute e di zelo sempre vivo per avvicinare la gente a Cristo - il modo giusto di essere vissuto e lo renderà un‘occasione di santificazione.
Il permanere in Cristo, con Dio, ci proietterà sempre verso gli altri, non smettendo mai di essere sacerdoti, mediatori in Cristo Gesù: con gioia e iniziativa, con il cuore aperto, disponibile per portare loro le cose di Dio, per avvicinarli al Signore.
In tal modo, tutto ciò che nella vita di noi sacerdoti è sanamente umano, vissuto secondo i sentimenti di Cristo, sarà sempre “ il luogo” nel quale ogni uomo e ogni donna possano incontrare Dio.
Ci sentiamo scossi, e il cuore batte più forte, quando ascoltiamo con attenzione il grido di san Paolo: Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione (1 Ts 4, 3). Oggi, ancora una volta, lo ripropongo a me stesso, lo ricordo a voi e a tutti gli uomini: questa è la volontà di Dio, che siamo santi.
Per dare la pace alle anime, ma una pace vera, per trasformare la terra, per cercare il Signore Dio nostro nel mondo e attraverso le cose del mondo, è indispensabile la santità personale. Nelle mie conversazioni con persone di tanti paesi e dei più diversi ambienti sociali, spesso mi sento domandare: «Che cosa può dire a noi che siamo sposati? E a noi che lavoriamo nei campi? E alle vedove? E ai giovani?».
Rispondo sistematicamente che ho "un'unica zuppiera" da offrire, e ribadisco che Gesù ha predicato a tutti la buona novella, senza distinzione alcuna. Una sola zuppiera e un solo alimento: Il mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato, e portare a compimento la sua opera (Gv 4, 34). Tutti sono chiamati alla santità, il Signore chiede amore a ciascuno: giovani e anziani, celibi e sposati, sani e malati, dotti e ignoranti, dovunque lavorino, dovunque si trovino. C'è un solo modo per crescere in intimità e in confidenza con Dio: frequentarlo nell'orazione, parlare con Lui, esprimergli — cuore a cuore — il nostro affetto.
Voi mi invocherete e io vi esaudirò (Ger 29, 12). Lo invochiamo conversando, rivolgendoci a Lui. Per questo dobbiamo mettere in pratica l'esortazione dell'apostolo: Sine intermissione orate (1 Ts 5, 17); pregate sempre, succeda quel che succeda. Non solo "di cuore", ma con tutto il cuore (SANT'AMBROGIO, Expositio in Psalmum CXVIII, 19, 12 [PL 15, 1471]).
Forse state pensando che la vita non è sempre agevole, che non mancano i dispiaceri, le pene, le tristezze. Vi risponderò, ancora con san Paolo, che né morte né vita, né angeli né principati, né virtù, né presente né futuro, né potestà, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù Signore nostro (Rm 8, 38-39). Niente ci può allontanare dalla carità di Dio, dall'Amore, dal rapporto costante con nostro Padre.
Raccomandare questa continua unione con Dio, non è forse proporre un ideale tanto sublime da risultare irraggiungibile per la maggior parte dei cristiani? Sì, la meta è davvero alta, ma non inaccessibile. Il sentiero che conduce alla santità, è un sentiero di orazione; e l'orazione deve attecchire nell'anima a poco a poco, come il piccolo seme che col tempo diverrà albero frondoso.
Cominciamo con le orazioni vocali, le stesse che molti hanno appreso da bambini: frasi ardenti e semplici, rivolte a Dio e a sua Madre, che è anche nostra Madre. Ancora oggi, al mattino e alla sera, e non una volta ogni tanto, ma abitualmente, rinnovo l'atto di offerta che i miei genitori mi hanno insegnato: Dolce mia Signora e Madre mia, io mi offro interamente a Voi. E in pegno del mio filiale affetto, vi consacro in questo giorno i miei occhi, i miei orecchi, la mia lingua, il mio cuore… Non è forse questo — in qualche misura — un inizio di contemplazione, una dimostrazione evidente di fiducioso abbandono? Che cosa si dicono coloro che si amano, quando si incontrano? Come si comportano? Sacrificano ciò che sono e ciò che posseggono per la persona amata.
Dapprima una giaculatoria, poi un'altra, e un'altra ancora… finché questo fervore appare insufficiente, perché le parole sono povere… e allora subentra l'intimità divina, lo sguardo fisso in Dio, senza soste e senza mai stancarsi. Si vive allora come in cattività, come prigionieri. Mentre svolgiamo con la massima perfezione possibile, pur con i nostri errori e con i nostri limiti, i compiti propri della nostra condizione e del nostro lavoro, l'anima vorrebbe fuggire. Ci si volge a Dio, come il ferro attirato dalla forza della calamita. Si comincia ad amare Gesù in un modo più efficace, con un dolce palpito.
Vi libererò dalla schiavitù, in qualunque luogo siate dispersi (Ger 29, 14). Ci liberiamo dalla schiavitù, per mezzo dell'orazione: siamo e ci sentiamo liberi, sulle ali di un cantico d'anima innamorata, un canto d'amore che ci sprona a desiderare di non separarci da Dio. È un modo nuovo di camminare sulla terra, un modo soprannaturale, divino, meraviglioso.
Ricordando tanti scrittori castigliani del Cinquecento, forse anche noi vorremmo assaporarne l'esperienza: vivo perché non vivo, è Cristo che vive in me (cfr Gal 2, 20).
Si accoglie allora con gioia il dovere di lavorare in questo mondo, e per molti anni, perché Gesù ha pochi amici sulla terra. Non ricusiamo il dovere di vivere, di spenderci — spremuti ben bene — al servizio di Dio e della Chiesa. Così: in libertà, in libertatem gloriae filiorum Dei (Rm 8, 21), qua libertate Christus nos liberavit (Gal 4, 31 [Vulg.]); con la libertà dei figli di Dio, che Cristo ci ha guadagnato morendo sul legno della Croce. (continua)
Dopo il tempo pasquale, la Chiesa ci conduce alla celebrazione dei grandi doni che Gesù ci ha lasciato nel suo passaggio terreno: in particolare la Solennità del Corpus Domini ci chiama a stringerci intorno al Sacramento del Corpo e del Sangue del Signore per ringraziare, per adorare, per farne sempre più la risorsa divina della nostra crescita secondo la vita nuova che Gesù ci ha conquistato.
“La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto un'esperienza quotidiana di fede, ma racchiude in sintesi il nucleo del mistero della Chiesa” (Ecclesia de Eucaristia, n.1). Se tutti i battezzati, innestati nel mistero della morte e risurrezione di Gesù, sono chiamati a maturare nell’Eucaristia la propria trasformazione in Cristo, noi presbiteri, attraverso l’Eucaristia, siamo chiamati anche a una partecipazione più intensa del sacerdozio di Cristo, e perciò: a diventare “più sacerdoti”.
La celebrazione dell’Eucaristia chiama ogni volta il cristiano ad un salto di prospettiva: da quella orizzontale, cioè dello sviluppo delle azioni, dei fatti, degli avvenimenti terreni, a quella verticale: secondo il percorso ascendente nel quale la grazia della Redenzione innalza la vita di quaggiù verso la vita divina, secondo le parole di Gesù: “quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”(Gv 12,32). Il sacrificio dell’Eucaristia e l’alimento che da esso scaturisce guidano il cammino di ciascuno e del mondo intero verso il Cielo.
Questo mutamento della prospettiva è sempre più urgente in questo “cambiamento d’epoca” che stiamo vivendo e che insieme ad aneliti del divino, porta con sé una forte proiezione sulle cose di quaggiù e anche molti cristiani vengono trascinati verso aspettative esclusivamente umane, mentre la fede sembra rimanere tante volte “una cornice”, talora sbiadita dove si va perdendo il rapporto personale di fede con il mistero di Cristo che è la radice, la sorgente del nostro vivere cristiano.
Anche noi sacerdoti possiamo essere tentati di sviluppare il ministero pastorale più su un piano orizzontale: nell’amministrare il culto per gli altri, nell’organizzare eventi religiosi, devozioni e tante iniziative pastorali, ecc. perdendo il rapporto vivo e trasformante con Cristo. Lo stesso sacrificio eucaristico, centro e radice del vivere cristiano e sacerdotale, può essere celebrato nell’esteriorità o nella routine, tralasciando quella viva unione con Gesù che si dona e ci chiama a donarci con Lui.
“nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini " ( Ecclesia de Eucaristia, n.1). Con la celebrazione della Messa siamo coinvolti, noi per primi e più profondamente, nel processo della Redenzione. Ce ne alimentiamo e lo celebriamo al servizio dei fedeli. Se “Ecclesia de Eucaristia”, anche il nostro ministero proviene dall’ Eucaristia ed esiste, prima di tutto, per l’Eucaristia: per edificare e fare crescere la Chiesa attraverso l’Eucaristia.
Nella celebrazione del Santo sacrificio siamo chiamati a maturare la nostra partecipazione allo spirito sacerdotale di Cristo: ad attualizzare in Lui il dono di noi stessi al disegno della Redenzione.
Sappiamo infatti che il sacerdozio dell’antica legge era solo un ministero di culto al servizio del popolo di Israele: non comportava un’immedesimazione del sacerdote con i sacrifici che celebrava mediante l’offerta di sé. Cristo, invece, - sacerdote e vittima - celebra il sacrificio come atto di donazione personale a lode, ringraziamento, riparazione ed espiazione; il culto del Nuovo Testamento che nasce con l’istituzione dell’Eucaristia è perpetuazione del culto reso da Cristo con il suo sacrificio. “Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione del suo Signore, questo evento centrale di salvezza è reso realmente presente e «si effettua l'opera della nostra redenzione" (Ecclesia de Eucaristia n. 11)
Da questa partecipazione viva e personale al sacrificio di Cristo, traiamo la forza per esprimere la sua forza redentrice nella nostra esistenza: nei pensieri, nella parole, negli affetti, nelle azioni e per avvicinare così gli uomini a Dio.
“(...) Dobbiamo tutti collaborare per celebrare sempre più profondamente l'Eucaristia: non solo come rito, ma come processo esistenziale che mi tocca nella mia intimità, più che ogni altra cosa, e mi cambia, mi trasforma. E trasformando me, dà inizio anche alla trasformazione del mondo che il Signore desidera e per la quale vuol farci suoi strumenti” (Benedetto XVI - Al clero 26.II.2009) La celebrazione dell’Eucaristia è dunque per noi presbiteri un cammino di assimilazione a Cristo, che ci fa “più sacerdoti” – mediatori in Cristo Gesù - in tutto il nostro essere e, con espressioni diverse, in ogni istante della nostra vita.
Così nella nostra esistenza concreta si manifesteranno – in continuità con la celebrazione eucaristica – la lode a Dio, il ringraziamento, l’impetrazione delle grazie necessarie alla salvezza degli uomini, la riparazione, per noi stessi e per tutti gli uomini.
Lo Spirito Santo ci va modellando nella sempre maggiore identificazione con i lineamenti dello spirito sacerdotale di Gesù. Saremo sempre più “ mediatori in Gesù Cristo”: non appartenersi per essere in ogni circostanza in mezzo agli uomini quel punto di congiunzione dell’umano con il divino. Cresceremo nell’amore alla volontà del Padre, nello spirito di obbedienza. “ Allora ho detto: «Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà” (Ebrei 10,7) e “ mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera”(Gv 4, 34). Impariamo a procedere nella ricerca gioiosa della volontà del Padre in obbedienza alla Chiesa: al Papa, al Vescovo … e allo Spirito che ci parla attraverso le esigenze quotidiane del nostro ministero pastorale, piuttosto che secondo i nostri progetti individuali.
Vivremo una vita di servizio, vorremo solo servire, nella dimenticanza di noi stessi: come il Figlio dell’uomo che “non è venuto per essere servito, ma per servire” (Mc 10,45); raccoglieremo, in tante circostanze, l’ appuntamento con lo spirito di servizio, piuttosto che di possesso, o di affermazione di noi stessi; ci renderemo disponibili alle giuste necessità degli altri. Crescerà in noi la compassione per tutti:” Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore” (Mt 9,36) ed “Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza” (Ebrei 5, 2). Accompagnati dalla consapevolezza dell nostra personale debolezza, sapremo accogliere e aiutare quanti sono caduti, si sono allontanati, si sono smarriti. Si accresce lo zelo sacerdotale per guidare i fedeli su cammini di santificazione e lo spirito missionario per far conoscere Cristo a tanti che sono ancora lontani da Lui.
Insomma, nella partecipazione viva al Sacrificio Eucaristico che celebriamo, crescer in noi la “carità pastorale”.
« La carità pastorale è quella virtù con la quale noi imitiamo Cristo nella sua donazione di sé e nel suo servizio. Non è soltanto quello che facciamo, ma il dono di noi stessi, che mostra l'amore di Cristo per il suo gregge. La carità pastorale determina il nostro modo di pensare e di agire, il nostro modo di rapportarci alla gente. E risulta particolarmente esigente per noi... ». (Pastores dabo vobis, n. 23)
«Questa carità pastorale — leggiamo nel Concilio — scaturisce soprattutto dal sacrificio eucaristico, il quale risulta quindi il centro e la radice di tutta la vita del presbitero, cosicché l'anima sacerdotale si studia di rispecchiare in sé ciò che viene realizzato sull'altare ». (Pastores dabo vobis, ibidem)
La celebrazione eucaristica unita al culto per l’adorazione del sacramento che permane, nei tabernacoli delle nostre chiese, sono pertanto, ogni giorno, la realtà più preziosa per la nostra vita sacerdotale e per la santificazione delle nostre comunità. A partire da essa tutto il nostro ministero acquista la sua fecondità.
“Lotta per far sì che il Santo Sacrificio dell'Altare sia il centro e la radice della tua vita interiore, in modo che tutta la giornata si trasformi in un atto di culto - prolungamento della Messa che hai ascoltato e preparazione alla successiva … “ (S. Josemaria – Forgia n.69)
“Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio" (Atti 1,3).
La liturgia del tempo pasquale ci aiuta a percorrere un cammino in qualche modo analogo a quello dei discepoli di Gesù: alla presenza del Risorto e alla luce della sue parole, in quei quaranta giorni, andarono scoprendo l’ampiezza e la profondità dei gesti e degli insegnamenti che Gesù aveva dato loro nei tre anni di vita con Lui. L’orizzonte della partecipazione in Lui alla stessa vita divina faceva risaltare quegli insegnamenti come manifestazioni di questa “vita nuova” che Gesù era venuto a conquistare anche per loro.
In particolare dovettero approfondire il contenuto dei discorsi particolarmente intimi che Gesù aveva intrattenuto con loro nell’ultima cena. Dovettero tornare sulla istituzione dell’Eucaristia e sul mandato loro affidato di esserne in futuro i ministri. Non sfuggì loro che i discorsi accorati di Gesù sul servizio e sull’amore fraterno che avevano caratterizzato quella sera erano in profonda relazione con l’istituzione dell’Eucaristia e la trasmissione fatta a loro del potere di rinnovarla.
C’è infatti una grande continuità tra di essi. “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35). Aggiungendo: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici" (Gv 15, 12-13). Gli insegnamenti di quella sera furono come il testamento spirituale del Signore: l’amore fraterno devrà impregnare la vita di coloro che saranno ministri dell'Eucaristia “in persona Cristi” e verrà alimentato continuamente dalla comunione al Suo Corpo.
La riflessione della Chiesa arriverà a identificare questo amore reciproco tra quanti sono chiamati al sacerdozio, sull’esempio di Cristo, come “fraternità sacramentale”: cioè dono di grazia e compito specifico di fraternità che procede dal sacramento stesso dell’Ordine sacro.
Durante tutto il tempo nel quale Gesù aveva avuto i dodici accanto a sé li aveva educati proprio a questa fraternità. Marco sottolinea che li chiamò: ”perché stessero con lui e per mandarli a predicare” (Mc 3,14). Egli desiderava che quello stare con Lui divenisse, prima di tutto, un cammino di comunione con Lui e fra loro, in una progressiva identificazione con i sentimenti del suo cuore.
Diversi episodi del Vangelo e insegnamenti del Signore erano rivolti prima di tutto a loro stessi: la necessità di farsi umili, le precisazioni a Pietro sul perdono, gli inviti a prestare l’altra guancia, a dare in prestito “anche il mantello”, a essere misericordiosi, ecc.
Così, in quegli anni, attraverso la comune amicizia personale con Gesù, andò crescendo fra quegli uomini, la capacità di stimarsi, di volersi bene, di perdonarsi, di aiutarsi, di esercitare un’autentica fraternità: unendosi sempre più alla persona di Gesù, ciascuno di essi veniva a partecipare anche dell’affetto con il quale Egli amava tutti gli altri.
Ci fa pensare quanto afferma Gesù allorché vennero a dirgli che sua madre e i suoi parenti lo cercavano, : “egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre» (Matteo 12,46-50). Gesù pone la relazione che per motivi soprannaturali si era stabilita tra Lui e gli apostoli - e fra loro stessi -, al di sopra di quella che Egli aveva con sua madre e i suoi parenti.
Infatti, la sorgente della loro unione con Cristo e tra di loro non proveniva da una loro scelta umana, ma dall’elezione divina.
Da quella radice si svilupperà ulteriormente la “fraternità ” che sarà conferita a loro come dono e compito nel momento li costituirà suoi ministri per i sacramenti della salvezza e, in particolare, per il sacramento dell’Eucaristia. Questa fraternità ormai “sacramentale” non si fonderà sulla simpatia umana, sulla sintonia su idee, sensibilità, ecc., ma sull’elezione divina e sulla grazia del sacramento.
La Chiesa ha riflettuto sulla realtà comunionale in cui nasce e si esercita il presbiterato:
« i presbiteri mediante il sacramento dell'Ordine sono collegati con un vincolo personale e indissolubile con Cristo unico sacerdote. L'Ordine viene conferito ad essi come singoli, ma sono inseriti nella comunione del presbiterio congiunto con il Vescovo (…) Questa origine sacramentale si riflette e si prolunga nell'ambito dell'esercizio del ministero presbiterale: dal mysterium al ministerium. « L'unità dei presbiteri con il Vescovo e tra di loro non si aggiunge dall'esterno alla natura propria del loro servizio, ma ne esprime l'essenza in quanto è la cura di Cristo sacerdote nei riguardi del Popolo adunato dall'unità della Santissima Trinità». (S. Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, n. 74)
Pertanto: “ Il ministero ordinato ha una radicale «forma comunitaria » e può essere assolto solo come «un'opera collettiva ». … Ciascun sacerdote, …, è unito agli altri membri di questo presbiterio, sulla base del sacramento dell'Ordine, da particolari vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità. (ibidem n.17)
Da questo, scaturisce la fisionomia della carità fraterna dei presbiteri: “La fisionomia del presbiterio è, dunque, quella di una vera famiglia, di una fraternità, i cui legami non sono dalla carne e dal sangue, ma sono dalla grazia dell'Ordine: una grazia che assume ed eleva i rapporti umani, psicologici, affettivi, amicali e spirituali tra i sacerdoti; una grazia che si espande, penetra e si rivela e si concretizza nelle più varie forme di aiuto reciproco, non solo quelle spirituali ma anche quelle materiali" (ibidem).
Con la grazia del tempo pasquale possiamo riconoscere e sviluppare maggiormente il dono e il compito della fraternità sacerdotale che è scaturito in noi col sacramento. Questo ci aiuta ad avere ben presente che il sacerdozio non è una conquista e un possesso personale, ma una grazia ricevuta, e che la scelta che il Signore ha fatto di ciascuno di noi ci unisce profondamente a tutti gli altri presbiteri. Da qui, secondo il comandamento di Cristo, deve nascere l’esigenza gioiosa di esercitare la carità reciproca, di sviluppare il “comandamento nuovo”: nella stima, nell’affetto, nell’aiuto, nel servizio verso i nostri fratelli sacerdoti.
Prima di tutto nella preghiera per loro: per il presbiterio diocesano, per quello universale e, con opportune graduazioni di responsabilità nella carità, verso i compagni di ordinazione, i sacerdoti con i quali collaboriamo più strettamente in una parrocchia, in una zona pastorale, ecc., : imparare così a guardarli con lo sguardo di Cristo e pregare per la santità di ciascuno.
Per promuovere la relazione fraterna, cogliendone la ricchezza che essa porta reciprocamente, è necessario superare le spinte “centripete” dell’individualismo che può nascondersi dietro la realtà dei molti impegni pastorali, che tuttavia non possono soffocare la relazione fraterna: essa si manifesterà nella cordiale partecipazione agli incontri diocesani, di zona pastorale, ecc. e nel coltivare la relazione personale con ciascuno secondo le opportunità che le circostanze di vita ci daranno.
Possiamo dare valore a tante piccoli segni di fraternità nella vita quotidiana: l’occasione di una telefonata per uno scambio di informazioni, per la richiesta di un consiglio, che diventa condivisione di gioie e preoccupazioni; sapersi fermare a casa di quel confratello, per un breve saluto, per mostrare la propria vicinanza al suo ministero. Talora sarà possibile e bello poter condividere un breve momento di preghiera o il pasto. È vero: abbiamo molte cose da fare, ma la cura della fraternità che Gesù ci chiede - nei modi ogni volta opportuni - viene prima ed è anche una grande testimonianza pastorale.
Inoltre,“La fraternità presbiterale non esclude nessuno, ma può e deve avere le sue preferenze: sono quelle evangeliche, riservate a chi ha più grande bisogno di aiuto o di incoraggiamento” (ibidem). Talora possiamo accorgerci che un nostro fratello sta passando un momento difficile: non possiamo voltargli le spalle, ma, oltre alla preghiera, dobbiamo anche con delicatezza farci più vicini e cercare l’opportunità di aiutarlo.
Lo spirito fraterno spingerà a una relazione personale che favorisca, nella confidenza, la reciproca conoscenza e promuova la possibilità dell’amicizia nel rispetto delle diversità di ciascuno. È facile stare solo con chi è più simile a noi e allontanarci da chi è diverso: la carità divina ci muove a promuovere la stima e la sincera fraternità nel rispetto delle diversità di carattere, di idee, di sensibilità. “La vera amicizia comporta anche uno sforzo cordiale per comprendere le convinzioni dei nostri amici, anche se non giungiamo a condividerle, né ad accettarle" (S. Josemaria - Solco 746).
Dobbiamo deciderci a voler bene comunque: ad avvicinarsi con quella benevolenza che lascia cadere qualche aspetto meno gradevole dell’altro e tiene invece lo sguardo sul valore di quel nostro fratello agli occhi di Cristo e sulle qualità e le virtù che egli possiede. Talora ci capita che, superando una iniziale antipatia verso chi è un po’ diverso da noi, si apra uno spazio inatteso di sincera amicizia che dà la gioia di condividere e anche di completarsi a vicenda.
E se, alle volte, qualcosa in un nostro fratello ci sembra ingiusto e inappropriato, dobbiamo trovare il modo garbato di poterlo manifestare all’interessato unendo la carità con la sincerità. In tal modo evitiamo di cadere nel risentimento, nel facile giudizio, nella mormorazione. “Non pensare mai male di nessuno, nemmeno se le parole o le opere di qualcuno te ne danno ragionevole motivo" (S. Josemaria - Cammino 442). Vogliamo imparare a ridimensionare, a dimenticare, a perdonare.
Pensando ai dodici e alla loro crescita nella fraternità - che tanto feconda è stata nella vita della Chiesa dei primi secoli - possiamo crescere anche noi nella capacità di viverla verso tutti i nostri fratelli sacerdoti, col pensiero costante a quelle parole del Signore: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35).
«Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro»
“Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: «Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto»” Mc 16 5-7.
Grande fu lo stupore di quelle donne che erano salite al sepolcro di buon mattino per andare a ungere con oli aromatici il corpo di Gesù, com’era consuetudine tra i Giudei. Non solo: “alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande”(ibi), ma, ciò che non prevedevano, era stata rimossa l’altra “grande pietra” che gravava sui loro cuori: la realtà della morte dolorosa è ignomimiosa del Maestro. Infatti il sepolcro era ormai vuoto: "videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”» (ibi).
Il “passaggio” dal grande dolore per la passione e morte del Signore alla grande gioia per la sua Resurrezione ebbe - per loro come per gli apostoli - i suoi tempi umani. Gesù li aiuterà a entrare un po’ per volta nella luce e nel calore di questo ”giorno che ha fatto il Signore”, che è sorto dalla Sua vittoria sul peccato e sulla morte. Per questo “Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio” (Atti 1,3)
Quei quaranta giorni prima dell’Ascensione del Signore al Cielo, fu per i discepoli un tempo di intensa maturazione, di progressiva crescita nella scoperta dell’orizzonte ampio e profondo che la Resurrezione di Gesù veniva ad aprire alla vita loro e di tutti gli uomini.
Fu per loro un passaggio non solo dal dolore per la passione e morte di Gesù e dal disorientamento che ne provenienza alla gioia di rivedere Gesù vivo, ma da un'idea che si erano fatti sulla Sua missone a una nuova e profonda comprensione di a che cosa li chiamassea quel “seguimi” che Gesù aveva rivolto a ciascuno di loro, sulle rive del mare di Galilea.
Qualcosa di questo cambiamento di prospettive ci viene mostrato dall’incontro di Gesù con i discepoli che, in quello stesso giorno, pur avendo avuto notizia del sepolcro vuoto, si allontanavano addolorati e delusi da Gerusalemme. “... erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso” Mc 24, 13-20.
Nell’apertura di cuore dei discepoli di Emmaus leggiamo la tristezza per un’aspettativa con la quale seguivano Cristo che era andata dolorosamente delusa. "Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute" Mc 24, 21
Anche poco prima dell'Ascensione, Luca riprende negli Atti una loro richiesta in proposito: "Quelli, dunque, che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?»" Atti 1,6.
Nella storia di Israele le aspettative che accompagnavano l’attesa della misteriosa figura del “messia” e la suo opera riguardavano prevalentemente la liberazione del popolo di Israele dall’assoggettamento ai popoli stranieri per una ricostituzione del “regno di Israele”. La realtà della morte del Messia e della succesiva e inattesa Risurrezione veniva a spalancare il vero orizzonte verso il quale Gesù voleva condurre loro e quanti lo avrebbero seguito: la liberazione dal peccato e la nascita a una “nuova vita”, il cui destino – già in questo mondo e pienamente alla fine dei tempi - non era un regno terreno, ma la partecipazione alla stessa vita di Dio. Fu questa profonda maturazione che li portò, guidati dall’azione dello Spirito, a proclamare il Vangelo a tutti gli uomini per chiamarli alla salvezza in Cristo. Per questo molti di loro, come il loro maestro, diedero persino la loro vita.
Anchea a noi, che ben conosciamo il vero significato della Redenzione operata da Cristo, le aspettative umane dei discepoli e la loro delusione fanno pensare a quelle aspettative umane che con frequenza possiamo nutrire nella nostra fedeltà a Cristo e nel ministero che realizziamo al suo servizio.
Ciò che per loro era l'attesa di un nuovo “ regno d’Israele” può essere talora per noi l'attesa di un cammino senza ostacoli e prove guidato dal successo umano, dell’affermazione di noi stessi e dall’approvazione sociale che il nostro operato come ministri della Chiesa debba raccogliere.
In contrasto con le attese dei discepoli, le vicende della passione e morte di Gesù furono chiaramente perdenti: Egli - mentre sparge le ricchezze della buona novella, dei miracoli, delle guarigioni, ecc. - trova tuttavia difficoltà e incomprensioni, opposizioni e accuse fino a dover subire la violenza della passione e della morte in croce. Ma tutto questo non fu per Gesù il fallimento della missione, bensì il passaggio attraverso il quale si compì, nel suo sacrificio, il disegno della salvezza dal peccato e dell'aprirsi delle le porte del Cielo.
“Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” Lc 24, 25-27. Se talora nel portare avanti il nostro ministero di servizio alla Chiesa ci ritroviamo delusi e disorientati rispetto alle nostre aspettative umane nell'incontrare contrarietà, incomprensioni, opposizioni, ecc. lasciamoci risvegliare da questo affettuoso richiamo di Gesù per riconoscere, invece in queste realtà di fatiche, incomprensioni e sofferenze, il cammino che, attraverso la partecipazione alla croce di Cristo, ci conduce verso la pienezza della vita in Cristo, alla sua Risurrezione.
Saremo aiutati a cercare con maggiore chiarezza “il Regno di Dio e la sua giustizia” non perché ci siano risparmiati fatiche e sofferenze umane, ma perché veniamo liberati dai vincoli del nostro io per vivere il nostro servizio ministeriale guidati solo dall’amore.
“Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero” Lc 24, 28-31. Nella celebrazione dell’Eucaristia si rivelò definitivamente alle loro menti il mistero della Croce e nei loro cuori si riversò tutta la gioia e la forza della fede. I loro occhi poterono riconoscere Gesù vivo e risorto, vincitore della morte e del peccato. ”Cristo vive. Gesù è l'Emmanuele, Dio con noi. La sua Risurrezione ci rivela che Dio non abbandona mai i suoi. (…) In modo speciale Cristo continua a essere presente fra di noi nel dono quotidiano dell'Eucaristia. Per questo la Messa è centro e radice della vita cristiana. (…) La presenza di Gesù vivente nell'Ostia è la garanzia, la radice e il culmine della sua presenza nel mondo” Josemaría Escrivá È Gesù che passa' n.102 . Ogni giorno, nella celebrazione piena di fede del Sacrificio eucaristico, si aprono i nostri occhi: possiamo riconoscerlo, vivo e risorto. e ci si rivela l’incedere del mistero della Redenzione in mezzo alle vicende della nostra vita e della vita del mondo.
“Se pensiamo che le cose non cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. (…). Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza, e non ci mancherà il suo aiuto per compiere la missione che Egli ci affida (…)
La fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è capace di intervenire misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il bene dal male con la sua potenza e con la sua infinita creatività. Significa credere che Egli avanza vittorioso nella storia insieme con «quelli che stanno con lui … i chiamati, gli eletti, i fedeli»” (Ap 17,14) (Papa Francesco – Evangelii Gaudium. n.275-278).
Siamo chiamati a innovare il cuore nella luce e nella forza della Risurrezione per abbandonare aspirazioni umane che possano pesare sul nostro ministero e che si rivelano inadeguate al disegno di Dio ed abbracciare ogni giorno, con la forza dell’Eucaristia, l’orizzonte ampio e profondo di cercare la pienezza della vita nuova in Cristo, per annunciarla e portarla a tutti gli uomini.
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni» (Lc 24,48).
Invocabit me et ego exaudiam eum, se mi invocherete vi ascolterò, dice il Signore(Sal 90, 15 [introito della Messa]). Considerate quanto è meravigliosa la sollecitudine di Dio verso di noi; è sempre disposto ad ascoltarci, sempre attento alla parola dell'uomo. In ogni tempo — ma ora in modo speciale, perché il nostro cuore è ben disposto, deciso a purificarsi — Egli ci ascolta e non sarà sordo alle richieste di un cuore contrito e umiliato (Sal 50, 19).
Il Signore ci ascolta per intervenire, per entrare nella nostra vita, liberarci dal male, colmarci di bene: Eripiam eum et glorificabo eum (Sal 90, 15 [introito della Messa]), ci libererà e ci glorificherà. Ecco la speranza della gloria: ritroviamo qui, come già in altre occasioni, l'inizio di quell'intimo movimento che è la vita spirituale. La speranza di questa glorificazione accresce la nostra fede e stimola la nostra carità. In tal modo le tre virtù teologali, virtù divine che ci fanno simili a Dio nostro Padre, diventano operanti.
Quale miglior modo di cominciare la Quaresima? Il rinnovamento della fede, della speranza e della carità è la fonte dello spirito di penitenza, che è desiderio di purificazione. La Quaresima non è solo un'occasione per intensificare le nostre pratiche esteriori di mortificazione: se pensassimo che è solo questo, ci sfuggirebbe il suo significato più profondo per la vita cristiana, perché quegli atti esterni — vi ripeto — sono frutto della fede, della speranza, dell'amore.
Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei coeli commorabitur (Sal 90, 1), abitare sotto la protezione di Dio, vivere con Dio: in questo consiste la rischiosa sicurezza del cristiano. Bisogna persuadersi che Dio ci ascolta, che è accanto a noi: e il nostro cuore si riempirà di pace. Ma vivere con Dio è indubbiamente un rischio, perché il Signore non si accontenta di condividere: chiede tutto. E avvicinarsi un po' di più a Lui vuol dire essere disposti a una nuova conversione, a una nuova rettificazione, ad ascoltare più attentamente le sue ispirazioni, i santi desideri che egli fa sbocciare nella nostra anima, e a metterli in pratica.
Certo, dai tempi della nostra prima decisione cosciente di vivere integramente la dottrina di Cristo, abbiamo fatto molti passi sulla strada della fedeltà alla sua Parola. Eppure, non è vero che restano ancora tante cose da fare? Non è vero che resta, soprattutto, tanta superbia? C'è indubbiamente bisogno di un nuovo cambiamento, di una lealtà più piena, di un'umiltà più profonda, affinché diminuisca il nostro egoismo e Cristo cresca in noi; infatti, illum oportet crescere, me autem minui (Gv 3, 30), bisogna che Egli cresca e che io diminuisca.
Non si può rimanere inerti. È necessario avanzare verso la meta indicata da san Paolo: Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me (Gal 2, 20). L'ambizione è grande e nobile: è l'identificazione con Cristo, la santità. D'altronde non c'è altra strada se si desidera essere coerenti con la vita divina che Dio stesso, mediante il battesimo, ha fatto nascere nelle nostre anime. Andare avanti significa progredire in santità; si retrocede, invece, se si rinuncia allo sviluppo della vita cristiana. Il fuoco dell'amore di Dio ha bisogno di essere alimentato, di crescere ogni giorno, di gettare profonde radici nell'anima; e il fuoco si mantiene vivo a condizione di bruciare cose sempre nuove. Se non avvampa, rischia di estinguersi.
Ricordate le parole di Sant'Agostino: Se dici basta, sei perduto. Guarda sempre avanti, cammina sempre, avanza sempre. Non restare allo stesso posto, non retrocedere, non sbagliare strada (SANT’AGOSTINO, Sermo 169, 15 [PL 38, 926]).
La Quaresima ci pone davanti a degli interrogativi fondamentali: cresce la mia fedeltà a Cristo, il mio desiderio di santità? Cresce la generosità apostolica nella mia vita di ogni giorno, nel mio lavoro ordinario, fra i miei colleghi? Ognuno risponda silenziosamente, in cuor suo, a queste domande e scoprirà che è necessaria una nuova trasformazione perché Cristo viva in noi, perché la sua immagine si rifletta limpidamente nella nostra condotta.
Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua (Lc 9, 23). È Cristo che ce lo ripete di nuovo, sottovoce, intimamente: la Croce ogni giorno. Non è solo — scrive san Gerolamo — in tempo di persecuzione e sotto la costrizione del martirio che dobbiamo rinnegare noi stessi quali eravamo in passato, ma in ogni attimo della nostra vita, nelle opere, nei pensieri e nelle parole; e dobbiamo far vedere che siamo degli esseri effettivamente rinati in Cristo (SAN GEROLAMO, Ep 121, 3 [PL 22, 1013]).
Queste considerazioni non sono, in realtà, altro che l'eco di quelle dell'Apostolo: Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore (Ef 5, 8-10).
La conversione è cosa di un istante; la santificazione è opera di tutta la vita. Il seme divino della carità, che Dio ha posto nelle nostre anime, aspira a crescere, a manifestarsi in opere e a produrre frutti che in ogni momento corrispondano ai desideri del Signore. È indispensabile quindi essere disposti a ricominciare, a ritrovare, nelle nuove situazioni della nostra vita, la luce e l'impulso della prima conversione. E questa è la ragione per cui dobbiamo prepararci con un approfondito esame di coscienza, chiedendo aiuto al Signore, per poterlo conoscere meglio e per conoscere meglio noi stessi. Se vogliamo convertirci di nuovo, questa è l'unica strada.
Exhortamur ne in vacuum gratiam Dei recipiatis (2 Cor 6, 1 [epistola della Messa]), vi esortiamo a non ricevere invano la grazia di Dio. La grazia divina potrà colmare la nostra anima in questa Quaresima, purché non chiudiamo le porte del cuore. Dobbiamo avere buone disposizioni, il desiderio di trasformarci veramente, di non giocare con la grazia di Dio.
Non mi piace parlare di timore, perché ciò che muove il cristiano è l'amore di Dio che è stato manifestato in Cristo e che ci insegna ad amare tutti gli uomini e l'intera creazione; dobbiamo però parlare di responsabilità, di serietà. Non vi fate illusioni — ci avverte l'Apostolo — , non ci si può prendere gioco di Dio (Gal 6, 7).
Bisogna decidersi. Non si può vivere con quelle due candele che, secondo il detto popolare, ogni uomo tiene accese: una a san Michele e una al demonio. Bisogna spegnere la candela del demonio. Dobbiamo consumare la nostra vita facendola ardere tutta intera al servizio di Dio. Se il nostro desiderio di santità è sincero e docilmente ci mettiamo nelle mani di Dio, tutto andrà bene. Perché Dio è sempre disposto a darci la sua grazia e, specialmente in questo tempo, la grazia per una nuova conversione, per un miglioramento della nostra vita di cristiani.
Non possiamo considerare la Quaresima come un periodo qualsiasi, una ripetizione ciclica dell'anno liturgico. È un momento unico; è un aiuto divino che bisogna accogliere. Gesù passa accanto a noi e attende da noi — oggi, ora — un rinnovamento profondo.
Ecce nunc tempus accettabile, ecce nunc dies salutis (2 Cor 6, 2 [epistola della Messa]): è il tempo propizio, l'occasione della salvezza. Si sente di nuovo il richiamo del Buon Pastore, la sua voce affettuosa: Ego vocavi te nomine tuo (Is 43, 1). Ci chiama per nome, a uno a uno, con l'appellativo famigliare con cui ci chiamano le persone che ci amano. La tenerezza di Gesù è inesprimibile.
Considerate con me quanto è meraviglioso l'amore di Dio: il Signore ci viene incontro, ci aspetta, attende lungo la strada in modo che non possiamo fare a meno di vederlo. E ci chiama personalmente, parlandoci delle nostre cose, che sono anche le sue: muove la nostra coscienza al pentimento, l'apre alla generosità e imprime nelle nostre anime il desiderio di essere fedeli e poterci chiamare suoi discepoli. Ci basta percepire queste intime parole della grazia, che suonano come un rimprovero sempre affettuoso, per renderci conto che Egli non ci ha dimenticati in tutto il tempo in cui noi, per nostra colpa, non ci siamo accorti di Lui. Cristo ci ama con l'amore infinito del suo Cuore divino.
Guardate come insiste: Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso (2 Cor 6, 2 [epistola della Messa]). Ti promette la gloria, il suo amore; te li dà al momento opportuno e ti chiama. E tu, che cosa dai al Signore? Come risponderai? Come risponderò io stesso all'amore di Gesù che passa accanto a noi?
Ecce nunc dies salutis, ecco, oggi è il giorno della salvezza. L'appello del Buon Pastore giunge sino a noi: Ego vocavi te nomine tuo, ho chiamato te, per nome. Bisogna rispondere — amore con amor si paga — dicendo: Ecce ego, quia vocasti me (1 Sam 3, 5), mi hai chiamato, eccomi: sono deciso a non fare che il tempo di Quaresima passi come l'acqua sui sassi, senza lasciare traccia; mi lascerò penetrare, trasformare; mi convertirò, mi rivolgerò di nuovo al Signore, amandolo come Egli vuole essere amato.
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente (Mt 22, 37). Che cosa resta del tuo cuore — commenta sant'Agostino — perché tu possa amare te stesso? Che cosa resta della tua anima e della tua mente? "Ex toto, Egli dice, con tutto". Totum exigit te, qui fecit te (SANT’AGOSTINO, Sermo 34, 4, 7 [PL 38, 212]), Colui che ti fece, ti vuole tutto. (continua per il testo integrale)
Nella liturgia del Battesimo del Signore abbiamo pregato: O Padre, il tuo unico Figlio si è manifestato nella nostra carne mortale, concedi a noi, che lo abbiamo conosciuto come vero uomo, di essere interiormente rinnovati a sua immagine. (Orazione colletta)
Nel nostro cammino di cristiani, l’azione dello Spirito Santo ci guida alla conformazione con l’Umanità di Cristo che diviene il luogo, il mezzo della nostra salvezza e della nostra santificazione, per entrare, in Lui, nella comunione filiale con Dio.
“Rivestitevi … del Signore Gesù Cristo” (Rom 13,14). La vita cristiana non è un mero osservare delle leggi, rispettare delle tradizioni, seguire dei comportamenti morali: è un incontro personale con Cristo, per essere trasformati secondo la Sua vita. Il Battesimo ci “innesta “ nella vita di Cristo e ci chiama a corrispondere all’azione dello Spirito “finché non sia formato Cristo in voi", dice San Paolo (Gal 4,19): cioè crescano in noi le sue disposizioni, i suoi sentimenti, i suoi desideri, le sue virtù. Se ciò vale per ogni cristiano: ancor più vale per noi sacerdoti, consacrati dall’Ordine sacro per esercitare il sacerdozio di Cristo ed essere tra gli uomini la “continuazione della vita e dell'azione dello stesso Cristo” (Pastores dabo vobis, n. 18). Un motivo in più - e una grazia specifica - per aprirci all’azione dello Spirito che lavora a questa conformazione.
Non possiamo, perciò, essere gli uomini della preghiera, della intensa attività pastorale, della proclamazione eloquente della parola di Dio e lasciare poi che nella nostra vita quotidiana si manifestino viltà, egoismi, intemperanze, disordine, bruschezza dei modi, cedimenti alla pigrizia, alla sensualità, alla mormorazione, alle gelosie e invidie. “Non crediamo che serva a qualcosa la nostra apparente virtù di santi, - ci ricorda San Josemaria Escrivà - se non va unita alle comuni virtù di cristiani. - Sarebbe come adornare di splendidi gioielli la biancheria intima” (Cammino 409).
Talvolta potremmo sottovalutare o sminuire il progresso nelle virtù umane nella nostra vita sacerdotale: “Una certa mentalità laicista e altri modi di pensare che potremmo chiamare 'pietisti' coincidono nel non considerare il cristiano come un uomo completo. Per i primi, le esigenze del Vangelo soffocherebbero le qualità umane; per gli altri, la natura decaduta metterebbe in pericolo la purezza della fede. Il risultato è lo stesso: si smarrisce il senso profondo dell'incarnazione di Cristo, si ignora che il Verbo si fece carne, uomo, e venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1, 14)” (S. Josemaría Escrivá, Amici di Dio, n.74). Può accadere che rinunciamo a cercarle perché sarebbe un mettere in secondo piano l’azione della grazia. Eppure sappiamo che la grazia non soffoca la natura, ma la guarisce e la porta a perfezione in Dio: essa, dunque, promuove l’umanità del cristiano nelle sue potenzialità.
“Se accettiamo la responsabilità di essere suoi figli, vedremo che Dio ci vuole molto umani. La testa deve arrivare al cielo, ma i piedi devono poggiare saldamente per terra. Il prezzo per vivere da cristiani non è la rinuncia a essere uomini o la rinuncia allo sforzo per acquistare quelle virtù che alcuni posseggono anche senza conoscere Cristo. Il prezzo di ogni cristiano è il Sangue redentore di Gesù nostro Signore che ci vuole — ripeto — molto umani e molto divini, costanti nell'impegno quotidiano di imitare Lui, perfectus Deus, perfectus homo”. (ibidem, n.75)
La santificazione sacerdotale deve dunque investire la nostra umanità che non è uno strumento inerte, ma trasmette la grazia anche nella misura in cui si sviluppa ed si esprime secondo l’umanità di Cristo. “Grazie a questa consacrazione operata dallo Spirito nell'effusione sacramentale dell'Ordine, la vita spirituale del sacerdote viene improntata, plasmata, connotata da quegli atteggiamenti e comportamenti che sono propri di Gesù Cristo Capo e Pastore della Chiesa e che si compendiano nella sua carità pastorale” (S. Giovanni Paolo II, Pastore dabo vobis, n.21). Infatti - aggiunge - “nell'esercizio del ministero è profondamente coinvolta la persona cosciente, libera e responsabile del sacerdote. Il legame con Gesù Cristo, che la consacrazione e configurazione del sacramento dell'Ordine assicurano, tende, per sua natura, a farsi il più ampio e il più profondo possibile, investendo la mente, i sentimenti, la vita, ossia una serie di « disposizioni » morali e spirituali corrispondenti ai gesti ministeriali che il sacerdote pone" (ibidem, n. 25).
In tal modo, attraverso i compiti e i gesti del ministero sacerdotale, cureremo la crescita secondo “gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil, 2 ,5). La virtù della pietà filiale che fa cercare continuamente l’unione con Dio Padre, come Gesù che, mentre svolgeva il suo incessante ministero, si raccoglieva nella preghiera al Padre e si dirigeva con frequenza a Lui per ringraziarlo – come prima della risurrezione di Lazzaro cfr. Gv 11,41) - o per benedirlo “perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11,25). La virtù della prudenza: visione di fede e capacità di discernimento della carità, come Gesù che decide di farsi carico e dare il cibo alle folle che da ore lo seguivano o che, prima di rispondere ai farisei, chiede loro quale autorità riconoscessero nel Battista. La virtù della giustizia, imparando da Gesù: a dare “ a Cesare , quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”, offrire a ogni persona che ci si avvicina ciò che le è dovuto davanti a Dio e agli uomini: rispetto, accoglienza, ascolto, stima, aiuto; ad essere giusti nei giudizi che dobbiamo dare a chi ci chiede luci.
La virtù della fortezza, imparando dalla fortezza di Gesù nella passione, a maturare la capacità di reggere le responsabilità del ministero, sempre appoggiati sull’azione della Provvidenza, in situazioni pastorali talvolta molto impegnative, senza facili ripiegamenti e scoraggiamenti o timori di fronte agli ostacoli; ad essere pazienti nel perdurare delle difficoltà, senza lasciarsi andare; ad essere audaci e coraggiosi: “Convinciti: quando si lavora per il Signore, non ci sono difficoltà che non si possano superare, né scoraggiamenti che inducano ad abbandonare l’impresa, né insuccessi meritevoli di questo nome, per quanto infruttuosi appaiano i risultati” (S. Josemaría Escrivá, Solco, n.110). La virtù della temperanza: una disposizione del nostro animo che possa renderci docili e pronti all’azione della grazia; che nella disciplina dei sentimenti, emozioni, stati d’animo, permetta di saper ascoltare, di essere attenti a comprendere in profondità le esigenze delle anime, e avere fermezza per prendere le opportune decisioni per il bene delle anime. “La sua disciplina interiore ed esteriore – ci dice Papa Francesco - consente il possesso di sé e apre spazio per l’accoglienza e la guida degli altri” (Discorso, 27 febbraio 2014).
Sincerità e lealtà. “Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno” (Mt 5,37): essere pastori affidabili che non tradiscano la fiducia, la parola data, nascondendo dietro “gli impegni” la poca voglia, la comodità, l’interesse; che rifuggano dalla doppiezza, delle illazioni, delle mormorazioni. Umiltà e longanimità per non insuperbire a causa del prestigio che il ruolo conferisce; per non presumere, ma saper ascoltare e imparare; per non essere suscettibili e permalosi. E concepire invece progetti grandi per la fede: saper sognare, saper promuovere nella nostra gente mete elevate di corrispondenza alla grazia: conversioni, ambizioni di santità, vocazioni speciali al servizio di Dio e della Chiesa, ecc. Laboriosità come Gesù che “cominciò a fare e a insegnare” (Atti 1,1). Una vita laboriosa – senza affanni o strattoni - ma continuamente e diligentemente impegnata nel servizio alle anime e alla Chiesa: ordine, orari, approfittare bene del tempo senza rimandare le cose e seguendo le priorità giuste.
Nella crescita dell’umanità di Cristo nella vita del prete deve maturare in particolare una carità incarnata in quelle virtù che hanno una maggiore rilevanza per il ministero di pastore e di padre che gli è affidato. Egli, infatti, è chiamato a “mettersi in cammino con i propri fedeli (...) condividendone gioie e speranze, difficoltà e sofferenze, come fratelli e amici, ma ancora di più come padri, che sono capaci di ascoltare, comprendere, aiutare, orientare. Il camminare insieme richiede amore, e il nostro è un servizio di amore” (Papa Francesco, Discorso, 19-IX-2013).
Forse talora sembrerà difficile poter cambiare aspetti del nostro modo di essere, eppure il Signore continua a dirci: “seguimi” e lo Spirito Santo è impegnato a “ formare Cristo in noi”. Con fede e disponibilità, un po’ alla volta avanzeremo, pur attraverso errori e arretramenti di cui chiederemo perdono per ricominciare, ma mirando sempre a “rivestirci del Signore Gesù Cristo”. Lo faremo percorrendo le vie della grazia che ci mettono in contatto con l'umanità di Cristo: il ministero della Parola, col desiderio che essa ci muova a continue conversioni; l’Eucaristia ricevuta come alimento che ci trasformi; la meditazione sull’umanità di Cristo che ci porti a desiderare sempre più la conformazione a Lui. E l’impegno della lotta nelle piccole cose, nei piccoli passi di ogni giorno che, a poco a poco, ci avvicineranno a Lui. A Maria e Giuseppe, che collaborarono alla crescita della umanità di Cristo, chiederemo che veglino anche sulla crescita dell’umanità di Cristo in noi.



.jpg)